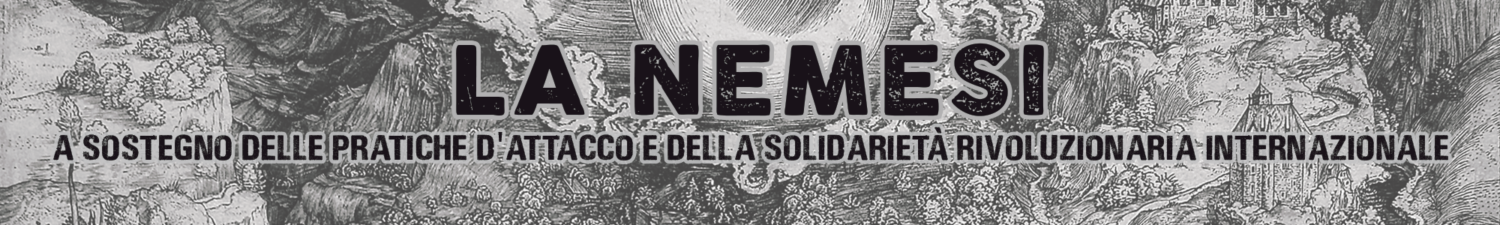Una critica anarchica al post-modernismo e al post-anarchismo
Il XX secolo, iniziato come un vortice rivoluzionario, si è concluso con il fallimento delle idee emancipatorie, dall’anarchismo al socialismo, “sconfitte” da un capitalismo che continuerà a mutare e trasformarsi in base alle proprie esigenze. Il dominio capitalista ha recuperato le antiche lotte “rivoluzionarie” sociali, economiche, ecologiche, ecc. Assorbendo molte di queste idee emancipatorie e inserendole nel proprio programma.
Da un lato, l’incapacità dei movimenti rivoluzionari di vedere e analizzare queste nuove ristrutturazioni capitalistiche e, dall’altro, il capitalismo con le sue infinite guerre e conflitti di dominio e di destabilizzazione di interi territori, o nella sua versione comunista con i suoi immensi pozzi di miseria morale e materiale rappresentati dai gulag, hanno portato allo sgretolamento dei movimenti rivoluzionari che, in più occasioni nel corso del XX secolo, avevano messo alle strette lo stesso capitalismo. Tutto ciò ha portato a una fuga generalizzata dai movimenti rivoluzionari, che successivamente hanno aderito alle idee della postmodernità, riuscendo a mettere un freno a tutte le aspirazioni di libertà ed emancipazione.
Di fronte al declino e alla crisi di questi movimenti rivoluzionari, sembra che molti abbiano trovato una via d’uscita nel ripiegamento sulla soggettività dell’individuo e nella fuga verso il mercato, visto come garante di una felicità basata sulla privatizzazione della vita (la distruzione della comunità) e sull’iperconsumo tipico della postmodernità. Merita una menzione particolare l’iperconsumo di identità.
Le idee della postmodernità, che oggi fagocitano completamente la sinistra e, in larga misura, i movimenti anarchici e rivoluzionari, sono il prodotto del disincanto nei confronti della politica, delle ideologie e dei movimenti sociali e rivoluzionari. Idee postmoderne che pongono l’individuo al centro e, grazie ai social network, l’individuo spogliato e atomizzato, allontanando la possibilità di una lotta rivoluzionaria che collochi al centro non le identità, ma la comunità e il collettivo, e che intraprenda nuovamente la lotta di classe, cercando la tensione, lo scontro e il conflitto che possano portare al crollo dell’ordine costituito.
Decretato lo stato di felicità permanente (slogan del maggio 1968)
La caduta del Muro di Berlino, la società di massa, lo svago, l’iperconsumo, il disincanto nei confronti delle idee rivoluzionarie, il ripiegamento individuale, la fine della guerra fredda… Tutto ciò ha portato all’affermazione della postmodernità. Durante la seconda metà del secolo scorso, si è gradualmente diffusa l’idea che tutto sia interpretabile e relativo e che le categorie che, fino a poco tempo prima, spiegavano il mondo, debbano essere aggiornate, reinventate e ridefinite. Che determinate categorie sociali, come Potere, Stato, capitalismo e movimenti rivoluzionari, fossero ormai superate e dovessero essere dissolte nel frullatore della storia. A partire dalla postmodernità, saranno rilevanti e degne di attenzione solo quelle questioni che procurano benessere a quel Soggetto disincantato per il quale l’aspirazione alla felicità individuale (o la visibilità dei propri problemi) costituirà d’ora in poi un sostituto funzionale di quelle idee rivoluzionarie che fino a poco tempo fa avevano un valore fondamentale. La postmodernità trasforma la ricerca del benessere soggettivo in un imperativo morale. Questo benessere comporta la privatizzazione della vita, una caratteristica strutturale della postmodernità: l’individuo si rifugia in se stesso, in un processo di progressivo isolamento. In assenza di un ambiente sociale e di una comunità, è lo Stato a prendere il loro posto. Lo Stato non è più il nemico da sconfiggere, ma il rifugio cui rivolgersi per rendere visibili i propri problemi. La perdita di quei progetti collettivi che illuminavano “un mondo nuovo” sarà “compensata” dall’individualismo, rappresentato da un individuo disincantato che cerca nuove fonti di soddisfazione in una società che gli offre nuove forme attraverso il mercato e gli promette un orizzonte di speranza basato sulla realizzazione dei suoi desideri più ardenti.
A poco a poco, il mondo delle idee si sgretola nella postmodernità. Non ci sono più religioni o idee rivoluzionarie a cui aggrapparsi; tutto acquista un carattere evanescente, cool, superficiale, effimero. Nella postmodernità non c’è più spazio per grandi progetti rivoluzionari, perché tutto ha un carattere relativo, transitorio, provvisorio. Tutto sembra discutibile, opzionale, relativo. La libertà non è più un progetto collettivo, ma si colloca ora al centro dell’esperienza individuale e tutto ciò che riguarda l’individuo, dalla nascita alla morte, acquista un significato politico: la scelta dei figli, il modo di alimentarsi, l’orientamento sessuale, la salute, il modo di consumare, ecc. Tutto è discutibile e trasformato in una merce in grado di soddisfare i desideri degli individui. Di conseguenza, le questioni riguardanti le condizioni strutturali della vita sociale, le condizioni di vita e la politica si allontanano dal centro della lotta e si concentrano sul singolo individuo.
Le idee postmoderne non devono essere ricondotte a una depoliticizzazione rigorosa: esse, infatti, sono inseparabili da un particolare entusiasmo relazionale, come dimostra la proliferazione di associazioni, gruppi di assistenza e gruppi riformisti. L’individuo postmoderno non è un individualista asociale, ma cerca connessioni e ramificazioni in collettivi con interessi iper-specializzati e miniaturizzati che non si pongono in conflitto con lo Stato o con il capitalismo. Cerca persone che condividono i suoi stessi desideri identitari: collettivi di “razzializzati”, gruppi di vegani, associazioni di “discas” [ndt. persone con disabilità], gruppi transfemministi, luoghi in cui praticare la solidarietà tra microgruppi, frammentando le lotte politiche e/o rivoluzionarie. L’individuo postmoderno forma una varietà di gruppi a cui non interessa più creare quei momenti di tensione o conflitto che potrebbero portare a una rivolta generalizzata. Così, nell’epoca postmoderna, l’individuo ha sostituito quella classe pericolosa che, con bombe, veleno, coltelli, libri e volantini, faceva tremare le fondamenta della borghesia. Una borghesia che ora offre a tutti una cultura e un consumo liberali a chiunque si travesta da rivoluzionario.
À la carte: scegli la tua ribellione
Lo spettacolo ha trasformato la lotta. I numerosi movimenti impegnati in lotte aleatorie non cercano più di proiettarsi per sovvertire l’esistente, per criticare il dominio o per pianificare lotte a lungo termine che possano scuotere il sistema. Ci troviamo nell’era tecnologica che predilige l’aspetto visivo: non solo si privilegia questo senso, ma si finisce per privarsi degli altri. La privazione sensoriale è un segno distintivo della società scientifica. Per questo oggi viviamo nell'”era della visibilità”, in cui le lotte devono essere rese visibili non più per essere diffuse come propaganda e raggiungere la coscienza della maggior parte della popolazione, ma per mostrare l’esistenza di un amalgama di soggetti che compongono la “ribellione liberale”, coloro che non intendono abbattere lo Stato o il capitalismo, ma semplicemente riaffermare se stessi e mostrarsi al mondo come se si trattasse di una vetrina commerciale.
A questo punto, la personalizzazione assume un’importanza particolare: un ampio menù, come al ristorante, dove scegliere la propria “ribellione”. Potremmo chiamarlo “scegli la tua avventura” o “costruisci il tuo viaggio”. Il capitalismo offre un consumo iper-individualizzato, con una moltiplicazione delle scelte che offrono sempre più opzioni e possibilità su misura, una sorta di self-service dell’esistenza “à la carte”, che consiste nel proporre a ogni persona diverse alternative. In questo modo, si sostituisce la normatività, l’autorità e la soggezione uniforme con la libera scelta, l’omogeneità con la diversità e l’austerità con la realizzazione dei desideri. Così, il capitalismo ti vende una “ribellione” in formato semplice. L’idea è semplice: la popolazione continua a consumare e a lavorare, ma senza essere soggetta alle vecchie norme autoritarie e alle coercizioni; ora sei “libero” di realizzare i tuoi desideri (quelli che il capitalismo ti ha confezionato con carta regalo). Così, questo stile di vita capitalista si è insinuato negli spazi refrattari, dedicati ora più spesso alla realizzazione personale, narcisistica, edonistica e identitaria, piuttosto che alla distruzione dell’esistente. La ribellione si maschera ora da identità: puoi scegliere quella che desideri (lo Stato spagnolo riconosce già 37 identità di genere, puoi scegliere quella che preferisci). Il mondo è diventato il supermercato delle identità. Esistono persino diverse identità legate all’alimentazione a cui viene attribuito un connotato ribelle. La norma ora è non essere normativi. Si può spingersi oltre e smettere di essere umani: cablarsi, impiantarsi chip, indossare un esoscheletro e riempire il proprio corpo di protesi per diventare transumani. Tutto è modellabile, tutto è un’opzione di consumo nel postmodernismo. Persino alcune “femministe” come Butler, Preciado o Haraway auspicano la trasformazione in cyborg, con la scusa di poterci reinventare a nostro piacimento e con l’obiettivo di superare la distinzione tra uomini e donne. Noi, in quanto refrattari e amanti della libertà, ci opponiamo categoricamente a tale aberrazione. Una volta dissolta la sua rigidità autoritaria, la società è diventata aperta, pluralista, attenta ai desideri degli individui e alla loro libertà, nonché alla flessibilità della vita nell’era del consumo, motivata da ragioni individuali. La sinistra ha fatto proprio questo modello di società e ce lo propina come qualcosa di ribelle. Così, i movimenti sociali, la sinistra e alcuni anarchici sono caduti nella trappola in cui la “lotta” si riduce al consumo di oggetti e segni artificiali che provocano la paralisi della rivolta e l’atomizzazione del sociale. In questo contesto, assistiamo alla distruzione “cool” del sociale e alle lotte per un processo di isolamento che non è più gestito dalla forza bruta o dal reticolo normativo, ma dall’edonismo, dal desiderio, dalla visibilità e dal consumo.
“Sono le classi a fare le rivoluzioni, non gli individui” Kropotkin.
Per noi, le diverse forme di sfruttamento e dominio non sono un problema in sé, ma piuttosto un problema complementare alla questione sociale. I discorsi politici che riducono lo sfruttamento e il dominio a diversi ambiti evitano di vedere la radice dei problemi comuni a tutti gli sfruttati. Questi discorsi (postcoloniali, neofemministi, neoecologisti, ecc.) sembrano abbandonarsi all’unica via d’uscita plausibile: la frammentazione sociale in base a criteri etnici, razziali, di genere, alimentari, ecc. Questa frammentazione sociale porta alla creazione di diversi gruppi che entrano in conflitto tra loro, dimenticando il vero nemico da combattere: la riproduzione sociale capitalista, il mondo mediato dalle merci e dalla tecnologia e il lavoro salariato. In questo terreno instabile scompaiono i modi di pensare comuni, così come un approccio al capitalismo. Da un lato, assistiamo a una ricomposizione della lotta in termini etnici, culturali, sessuali, ecc., e dall’altro, notiamo che le analisi e le pratiche critiche nei confronti dello sfruttamento economico o della riproduzione sociale non sono più all’ordine del giorno. Le lotte frammentarie non mirano a distruggere l’esistente né, tantomeno, a provocare tensioni e conflitti che possano sfociare in una rivolta generalizzata. L’obiettivo di queste lotte di sinistra è cambiare in meglio lo sguardo sulle persone. Voler rendere visibile, voler cambiare la percezione che si ha degli altri e comprendere il funzionamento della loro “comunità” non implica necessariamente modificare la situazione di sfruttamento in cui si trovano.
In altre parole, rendere visibili o cercare di cambiare il modo in cui certi gruppi (sessuali, etnici, ecc.) sono visti non è una lotta rivoluzionaria: è la sinistra che fa il suo lavoro di recupero delle lotte e che detta la direzione da seguire. Così, il multiculturalismo e la difesa pubblica delle minoranze rischiano di diventare i migliori garanti di un ordine capitalista che produce la grande differenza strutturale: quella tra ricchi e poveri. In tutte queste lotte parcellizzate, la guerra di classe viene dimenticata. Come afferma Walter Benn Michaels, «la diversità non è un mezzo per instaurare l’uguaglianza; è un mezzo per gestire la disuguaglianza. Dal punto di vista politico, non ha nulla di radicale. Mettere in evidenza o glorificare la diversità […] oggi non è altro che il nostro modo di accettare la disuguaglianza». L’unica cosa che viene cancellata con la diversità e queste lotte frammentarie è la differenza tra le classi. Il nemico da sconfiggere non è più la società di classe, ma si mira ora all’inclusione di tutti in essa, creando una società di classe diversificata.
L’ideologia di sinistra ha fatto breccia in alcune idee refrattarie e gli anarchici sono riusciti a frammentare le lotte, lasciando penetrare parte del programma di sinistra nei propri progetti, che sono così caduti in una paralisi e in sterili lotte interne senza precedenti, una volta messi da parte temi come lo Stato, il Capitale, le merci e il lavoro salariato. I sinistroidi hanno avuto campo libero per riorganizzare “l’agenda” politica in termini di lotta contro il potere delle norme piuttosto che contro un sistema capitalista che produce alienazione, miseria, povertà ed ecocidio. Questa lotta è diventata superficiale: non si tratta più di operare una critica o un attacco contro i nostri nemici, ma di “decostruire” il pensiero, le idee e i postulati dell’avversario.
Una breve critica al post-anarchismo
Ribadiamo che le idee di sinistra si sono infiltrate nell’anarchia e talvolta la loro logica impregna le riflessioni di molti anarchici. Idee provenienti dalla “sinistra radicale”, da alcuni bastardi come Foucault, Deleuze e Guattari, ma anche dalle nuove femministe come Butler o Haraway, o dalle teorie postcoloniali. Uno dei primi a usare il termine “post-anarchismo” fu Hakim Bey, famoso per il suo libro T.A.Z. (ZONE TEMPORANEAMENTE AUTONOME). Questo autore era un fautore del postmodernismo che utilizzava l’anarchia per dare libero sfogo alle proprie follie. Tra le sue varie “perle”, osservava che il potere non è altro che pura “simulazione” o che “la pornografia e il divertimento popolare sono veicoli di una rieducazione radicale”. Non capiremo mai come questo autore abbia avuto tanto “successo” in certi ambienti anarchici, forse per il suo linguaggio radicale/situazionista o forse perché presentava qualcosa di nuovo; non lo sapremo mai. Vengono rimosse le basi del pensiero anarchico, come il “potere”, inteso come sfruttamento e dominio dei ricchi sui poveri. Anche Foucault sosteneva che il potere fosse qualcosa di “astratto”. Così si è formato il post-anarchismo. Per questi autori, che si nascondono dietro l’inganno del post-anarchismo, tutto è modellabile e fluido, pertanto si spingono fino a ridefinire l’anarchismo, che per loro non dovrà rappresentare un’aspirazione rivoluzionaria, ma la decostruzione del sociale sotto la maschera di una spettacolare ribellione individuale. In questo modo, cercano di destabilizzare tutto ciò su cui si basa l’anarchismo classico. Pretendono di portare il loro modello di mondo malleabile e fluido all’interno dell’anarchismo. In questa “rivisitazione” dell’anarchismo troviamo sciocchezze come quelle della canadese Sandra Jeppesen, docente universitaria, che afferma: “L’anarchismo non è un movimento bianco, […] l’anarchismo non è un movimento di monogamia eterosessuale binaria […] l’anarchismo non riguarda il lavoratore […] l’anarchismo è produrre avvenimenti”. Anche se non è divertente, non possiamo fare a meno di sorridere di fronte a una tale idiozia. L’anarchismo non coinvolge il lavoratore? Bisogna ammettere che, a meno che non si voglia cancellare il passato e chiudersi nell’immediatezza del momento, è singolare e sbagliato affermare una cosa del genere riguardo a un movimento nato nel 1872 da una scissione dall’Associazione Internazionale dei Lavoratori, dalla quale erano stati esclusi Bakunin e Guillaume.
Vogliono distruggere l’anarchia, ma non lo permetteremo: siamo testardi come i nostri compagni del XIX secolo che attaccavano con tutte le loro forze chi cercava di annientarli. Oggi il nemico attacca da sinistra. Ci chiediamo a chi si rivolga quell’anarchismo che non è “per il lavoratore”. Il post-anarchismo riduce l’azione politica alla sovversione dell’identità e il suo pensiero decostruzionista rende impossibile concepire la critica in termini di alienazione o sfruttamento. Ci ritroviamo così in assemblee e luoghi in cui si antepone “il pronome di ciascuno”, “la sua identità sessuale” o “ciò che mangia” alla realizzazione di progetti che, con la loro prassi e critica, possano far vacillare questo mondo che ci condanna alla miseria. Un chiaro esempio è dato dal femminismo: da un lato abbiamo le femministe radicali che lottano contro il sistema patriarcale e i meccanismi oppressivi, dall’altro il neofemminismo/queer che cerca esclusivamente di destabilizzare le norme, dispiegando la propria politica in un vuoto sociale e esacerbando lo slogan “il personale è politico” fino a dissolvere la politica nella reinvenzione della sessualità. In questi discorsi del cosiddetto post-anarchismo scompare ogni critica alla vita mutilata dalle merci, dal lavoro salariato o dalla tecnologia.
L’attuale “spettro anarchico” sembra incapace di liberarsi da questo cocktail postmoderno e di sinistra che modella il modo di agire, pensare e sentire all’interno dei nostri ambienti. Il risultato è che il pensiero all’interno dei movimenti anarchici diventa sempre più rigido e omogeneizzato, con poche possibilità di criticare il pensiero unico post-anarchico che si sta diffondendo a macchia d’olio. Questi movimenti post-anarchici sono spesso composti da personaggi autoritari che, sotto le spoglie di un’ideologia “gentile”, rendono impossibile il dibattito o l’approfondimento di certi aspetti, nonché qualsiasi critica, pena l’espulsione dal loro “grande fratello”. Cercare di frammentare l’anarchismo categorizzando le persone in base ai loro privilegi e alle loro capacità. Incolpando l’altra parte di essere abilista e privilegiata. Dare a tutto ciò un tono da ribelli non è altro che una farsa priva di qualsiasi valore rivoluzionario. L’anarchismo, attraverso il sostegno reciproco e la solidarietà, risolve i problemi legati alle abilità o ai privilegi senza la necessità di stabilire categorie sociali; trasformare parte della popolazione in vittime fa parte del discorso capitalista, assorbito da coloro che dicono di opporsi a esso. Guardare di nuovo in faccia il nemico, scrutare senza paura l’abisso apre possibilità di insurrezione; creare categorie e frammentare il movimento rivoluzionario serve solo a perpetuare l’esistente. Qui l’anarchia funge da veicolo per la tirannia. È straordinariamente facile biasimare un ambiente privo di scrupoli e paralizzato dall’ansia all’idea di proibire o imporre qualcosa, atteggiandosi a “vittime”, “rappresentanti dei dominati”, “oppressi” o “discriminati” delle minoranze. Questi attivisti, sostenuti e celebrati dalle università, dalle case editrici, dal mondo dello spettacolo e dai media, sono gli agenti ideologici della tecnocrazia transumanista, impegnati a distruggere tutte le forme di difesa di un’umanità libera in una natura selvaggia.
Chimpancés del futuro [Scimpanzé del futuro]
Madrid, ottobre 2025
[Ricevuto via e-mail | Pubblicato in spagnolo in https://barcelona.indymedia.org/newswire/display/537159 | Pubblicato in tedesco in https://panopticon.noblogs.org/post/2025/10/20/eine-anarchistische-kritik-an-der-postmoderne-und-dem-post-anarchismus/ | Tradotto in italiano e pubblicato in https://lanemesi.noblogs.org/post/2025/10/30/una-critica-anarchica-al-post-modernismo-e-al-post-anarchismo/]