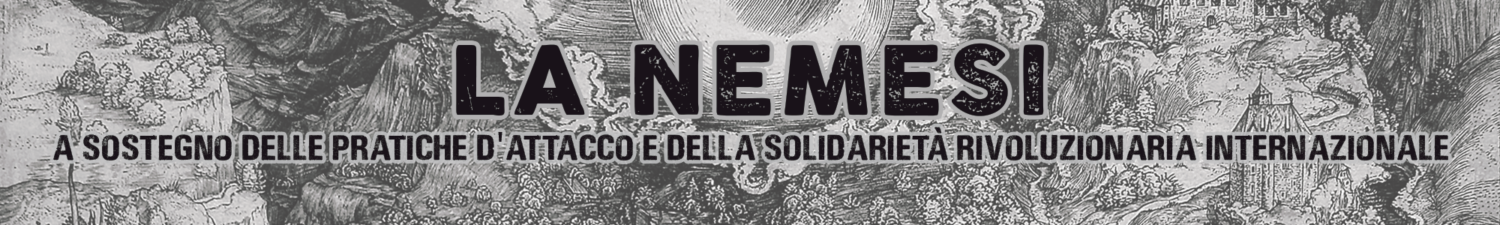Sulle solite vecchie – amate – questioni
A proposito di comunismo e individualismo (con disimpegno a vista sul nichilismo)
Ci sono questioni su cui si arrovella l’anarchismo che ciclicamente tendono a tornare. La più classica di queste è l’eterno dibattito su comunismo e individualismo. Quando parlo di comunismo e individualismo intendo naturalmente il comunismo anarchico e l’individualismo anarchico. Non aggiungerò sempre l’aggettivo «anarchico», anzi non lo farò quasi mai per risparmiare parole e agevolare la lettura. Lo si dia quindi per scontato (oltretutto mi sembra un buon metodo per impedire la perdita, l’alienazione e l’esproprio di queste belle parole).
Ed è una fortuna che lo si faccia perché i risultati che raggiunge il dibattito non andrebbero mai postulati come acquisiti, ma ogni generazione e ogni singolo compagno dovrebbe ogni volta riconquistarli nella propria formazione.
L’occasione per tornare a parlarne me la forniscono alcune critiche che sono giunte a un paio di articoli pubblicati nel numero 7 del giornale anarchico “Vetriolo”, l’ottavo (perché siamo partiti dal numero 0) e ultimo numero che abbiamo pubblicato. Bene che si sia pubblicato anche questo ultimo numero nell’estate del 2022, numero successivo all’operazione repressiva che ci ha coinvolto nel novembre del 2021, perché lungi dal risultare un disperato modo per dire «non ci farà chiudere la repressione» (per poi chiudere, giusto per dispetto, dopo un solo altro numero), è invece riuscito a essere un momento di ricapitolazione e rilancio del lavoro teorico svolto in diversi anni di pubblicazioni, a tal punto che a oggi continuiamo a ricevere osservazioni e critiche proprio su articoli di quest’ultima edizione del giornale.
In sintesi negli ultimi mesi sono stati divulgati i seguenti contributi:
- Un testo di Juan Sorroche, scritto dalla sezione AS2 del carcere di Terni dove si trova recluso, in polemica con l’articolo L’anarchismo rivoluzionario contro la desistenza, pubblicato sul numero 7 del giornale anarchico “Vetriolo”: Individualismo anarchico conto comunismo anarchico? Oppure comunismo anarchico con individualismo anarchico? pubblicato sul numero 15 della rivista anarchica «i giorni e le notti» nel giugno del 2024 (datato marzo 2024).
- Due nuovi testi, sempre di Juan dal titolo rispettivamente Il mutuo accordo dell’anarchismo rivoluzionario non-sistemico e Una cattiva interpretazione del concetto dell’individualismo anarchico, entrambi datati 30/01/2025 e pubblicati qualche settimana dopo. Come il precedente (al quale, facciamo ammenda, non avevamo ancora risposto), anche per quanto riguarda i nuovi contributi trattasi di documenti critici nei confronti dell’articolo L’anarchismo rivoluzionario contro la desistenza. Possono essere letti a questo link: https://ilrovescio.info/2025/03/05/il-mutuo-accordo-dellanarchismo-rivoluzionario-non-sistemico-di-juan-sorroche/
- Nel frattempo sempre in quelle settimane usciva un contributo anonimo dal titolo Alcune considerazioni critiche su “La fase nichilista”. Evidentemente una critica al nostro scritto La fase nichilista pubblicato sul numero 7 del giornale anarchico “Vetriolo”. Il contributo veniva originariamente inviato in occasione del dibattito previsto a Foligno all’interno del laboratorio teorico previsto nel programma delle ormai tradizionali iniziative della “Befana”. Purtroppo però in quella occasione non abbiamo letto l’email in tempo e non abbiamo potuto discuterne; questa quindi sarà la prima risposta pubblica al compagno. Successivamente pubblicato anche dai siti internet del movimento anarchico è leggibile per esempio a questo link: https://lanemesi.noblogs.org/post/2025/02/06/alcune-considerazioni-critiche-su-la-fase-nichilista/
- Infine, il sito in lingua tedesca https://panopticon.noblogs.org/ ha recentemente pubblicato la traduzione proprio de La fase nichilista, introdotta da una breve ma densa nota critica. In italiano è leggibile a questo link: https://lanemesi.noblogs.org/post/2025/07/25/breve-introduzione-critica-alla-traduzione-e-pubblicazione-in-lingua-tedesca-dellarticolo-la-fase-nichilista-contenuto-nel-numero-7-del-giornale-anarchico-vetriolo/, all’interno del quale si possono trovare i collegamenti con l’originale in lingua tedesca e altre traduzioni (i compagni di panopticon hanno tradotto anche il documento critico anonimo divulgato a gennaio in italiano).
Ricordo che il numero 7 di “Vetriolo” e diverse delle precedenti uscite sono ancora disponibili e possono essere richieste a questo indirizzo: vetriolo@autistici.org.
Più che una risposta lineare – botte e risposte – ai compagni che hanno fatto lo sforzo di aprire un dialogo e un polemica sulle nostre ipotesi teoriche, quello che segue spera di risultare come un documento autonomo, disponibile per tutti quelli che lo reputano utile, di verifica e di aggiornamento delle analisi all’interno del quale provare a replicare anche alle osservazioni che ci sono state mosse. Scrive Juan Sorroche di avere utilizzato «lo scritto di “Vetriolo” come stampella e per così sviluppare le mie idee con più linearità d’analisi e di critica, più complessive»; dato che è un metodo che condivido – perché a mio avviso ci permette di crescere ed esplorare più dimensioni, nonché di scrivere qualcosa di più interessante di una semplice discussione lineare (che può sempre svolgersi in forma privata) – io farò esattamente la stessa cosa.
Infine mi sembra giusto informare che io sono l’autore de La fase nichilista, ma non sono l’autore de L’anarchismo rivoluzionario contro la desistenza. Naturalmente mi assumo la responsabilità e la piena condivisione di fondo di tutto il materiale pubblicato negli anni su “Vetriolo”, non posso però entrare, rispetto agli articoli che non ho scritto, su un dibattito troppo tecnico e bibliografico (per esempio, Juan rimprovera all’autore di non aver davvero letto l’opera di Armand; di questo ovviamente non rispondo).
Breve storia di una critica al Vetriolo
Un ripasso della storia teorica di “Vetriolo” forse si impone perché almeno un paio dei cinque contributi critici che abbiamo ricevuto dimostrano di trascurare o di non conoscere il percorso nel quale sono maturate certe affermazioni, finendo per equivocarle.
Nei primi numeri “Vetriolo” ci si è concentrati in particolare su un dibattito che all’epoca tormentava molto l’anarchismo (in particolare quello di lingua italiana), ovvero l’intervento degli anarchici all’interno delle lotte sociali. Il dibattito vedeva contrapposte due fazioni: i cosiddetti anarchici sociali e i cosiddetti anarchici anti-sociali. Già attivo da diverso tempo, all’epoca il dibattito stava assumendo forme nevrotiche.
Il numero 0 di “Vetriolo” usciva nell’inverno 2017. Su questo scontro tutto interno all’anarchismo, abbiamo sostenuto quella che potremmo definire una sorta di rivoluzione copernicana: la questione non è dichiararsi astrattamente «sociali» o «antisociali», bensì classisti. Gli anarchici dovrebbero dunque essere scettici verso quelle lotte sociali di tipo interclassista, le lotte popolari, le lotte ambientaliste, i movimenti di liberazione nazionale, i movimenti di liberazione delle cosiddette categorie oppresse (scettici non significa per forza non farne parte); ma non dovrebbero essere estranei alla lotta di classe, anzi dovrebbero intervenirvi, soprattutto non dovrebbero essere alieni a una lettura di classe della realtà (la quale piuttosto illumina di una diversa e più nitida colorazione, anche le lotte sociali generiche). Viceversa per degli anarchici definirsi antisociali non ha alcun senso, perché tutta la critica anarchica, l’essenza stessa della tensione anarchica ha a che fare con una frattura originaria che è intimamente e inestricabilmente sociale.
Pertanto alla dicotomia tra «sociale» e «antisociale» proponevamo di sostituire, non tanto la fine delle dicotomie, bensì una diversa e radicale dicotomia: quella tra frontismo e internazionalismo. Laddove l’espressione «frontismo» indica la strategia messa in atto a partire dagli anni Trenta dello scorso secolo di costituire, dinnanzi all’avanzare del pericolo fascista e nazista, di ampi fronti popolari, ovvero di alleanze fra partiti, sindacati e altri grandi organizzatori collettivi appartenenti a classi sociali diverse. Con la strategia del frontismo, quindi, si postula che il fascismo è il male assoluto e che contro questa maledizione la lotta di classe va messa in secondo piano. A teorizzare e mettere in pratica il frontismo sono stati innanzitutto partiti marxisti di varie colorazioni, stalinisti e socialdemocratici in origine, seguiti nel dopoguerra dal frontismo straccione del maoismo e del guevarismo che recuperava le lotte di liberazione nazionale originariamente espressione delle borghesie dei Paesi oppressi (giusto per ricordare all’ignorante di turno che i primi ad abbandonare la lotta di classe a favore delle alleanze politiche siano stati i marxisti e le che talune categorie postcoloniali sono molto più staliniste-maoiste che libertarie).
Col concetto di internazionalismo si intendono invece niente di più – giacché l’originalità non dovrebbe essere un vezzo – che quei principi espressi dall’internazionale anarchica nel terzo punto della risoluzione del congresso di Saint Imier del 1872: «respingendo ogni compromesso al fine di attuare la rivoluzione sociale, i proletari d’ogni paese devono stabilire, al di fuori di ogni politica borghese, la solidarietà nell’azione rivoluzionaria». Rifiuto dei compromessi politici, nessuna alleanza con la borghesia del proprio Paese, ma solidarietà nell’azione rivoluzionaria fra i proletari di ogni Paese.
L’invettiva dei compagni di panopticon – «La società di classe definisce una società antagonista inconciliabile, una condizione economicamente imposta che non rappresenta un’identità; il populismo, invece, unisce (suggerisce questa unificazione/associazione) e esiste solo come fantastica IDENTITÀ interclassista» – è corretta ma francamente è inviata all’indirizzo sbagliato. La vicenda teorica di “Vetriolo” è sin dal concepimento inserita all’interno di questo orizzonte. Semmai i compagni di panopticon temo che siano vittime di una particolare paranoia delle parole, una paranoia che troviamo talvolta in alcune sette – questa volta sì marxiste – ultraminoritarie. Non bisogna avere paura di bestemmiare la buon anima di Bordiga perché si è usata la parola «popolo» o «populista», bisognerà pur vederne il contesto. E lo vedremo meglio più avanti, il contesto.
D’altro canto sono gli stessi Bakunin e compagni che usano l’espressione «Paese» nel passaggio citato, così come Bakunin parla di popolo in numerosissimi passaggi (spesso persino in contrapposizione con la classe germanicamente intesa da Marx come la superiore classe fabbrichista socialdemocratica). E d’altronde noi siamo internazionalisti, non siamo mica cosmopoliti, postidentitari, a-nazionali o uccelli migratori (semmai anche questa è una deriva di una certa estrema sinistra del capitale, dove il cosmopolitismo poi diventa sempre l’americanizzazione del cosmo). Dunque popoli, nazioni e Paesi esistono – il mondo è bello perché è vario, diceva mia nonna – semplicemente noi non siamo per i fronti popolari e nazionali (interclassisti) ma per la solidarietà nell’azione rivoluzionaria tra i proletari dei vari popoli, nazioni e Paesi del mondo.
Nel frattempo la storia di “Vetriolo”, fortunatamente, è proseguita uscendo da questo dibattito tutto interno all’anarchismo, assumendone i risultati come premessa, per affrontare questioni teoriche, analitiche e pratiche più interessanti. Vado molto velocemente su alcune di queste, non perché non siano importanti, ma perché ci portano fuori dal presente dibattito. Per esempio sul lato teorico, per quattro numeri (dal numero 0 al numero 3) si è provata a sviluppare una teoria anarchica dello Stato, laddove lo Stato veniva visto non solo come un semplice sistema d’allarme marxiano a difesa della villa dei padroni, ma come un organismo vivente, il quale emergendo dalla sua funzione di classe prendeva una propria vita ideologica, simbolica, una propria personalità. Lo Stato non è il potere in generale, ma potere politico organizzato (la nostra lotta è quindi una lotta storica, contro un nemico reale e personale, non una lotta esistenziale contro un metafisico e pertanto imbattibile dominio). Sempre negli stessi primi quattro numeri un compagno ha abbozzato una controstoria della sinistra e delle sue infamità controrivoluzionarie, riletta polemicamente all’interno delle categorie andavamo proponendo. E ancora, abbiamo avuto una serie di scambi felicemente polemici con un compagno che scriveva articoli su un altro giornale anarchico, “i giorni e le notti”, intorno alla categoria del fascio-leghismo (noi eravamo contrari all’uso di questa categoria, scettici verso la denuncia di una fascistizzazione della società, in generale nemici di ogni fronte antifascista; ma sto andando davvero troppo veloce, fu un dibattito lungo e arricchente).
Per tre numeri (dal 2 al 4, 2018-2020) abbiamo sviluppato una serrata, complicata e coinvolgente discussione epistolare con Alfredo Cospito dal carcere di Ferrara. Partendo dall’assunto internazionalista, avevamo cominciato a elaborare in diversi articoli la necessità del passaggio dall’internazionalismo all’internazionale; quindi della costruzione di una organizzazione specifica mondiale insurrezionale degli oppressi. Dopo alcuni anni e pagine di discussioni abbiamo coinvolto anche Alfredo, ponendogli la fatidica domanda: Quale internazionale? La proposta teorica e pratica di Alfredo è nota – una internazionale informale, che dialoghi attraverso l’azione, nemica del capitalismo certo, ma soprattutto della scienza, nichilista e al contempo capace di risvegliare il mito dell’anarchia vendicatrice – così come sono noti gli esiti editoriali (ne uscì un libricino delle Edizioni Monte Bove, corredato da una ricca appendice contenente tra l’altro la cronologia di tutte le azioni della Federazione Anarchica Informale avvenute in Italia) e soprattutto sono noti gli esiti giudiziari, nonché la determinazione da parte dello Stato nel trasferire in 41 bis il compagno proprio per provare a tappargli la bocca.
Ma un giornale come “Vetriolo” era ancora molto altro; abbiamo ricevuto contributi poetici e artistici, abbiamo pubblicato una serie di articoli solo apparentemente indipendenti (contro l’ossessione della coerenza, in difesa del concetto di insurrezionalismo, sulla natura della mafia non come segno di arretratezza ma come avvenire del capitalismo, sulla repressione) in realtà espressione di uno stesso progetto editorialmente orientato, così come abbiamo pubblicato negli anni delle analisi sulla situazione del momento ispirate da quelle stesse categorie, ancora nell’ultimo numero abbiamo sostenuto una chiara presa di posizione disfattista e internazionalista sulla guerra mondiale regionalizzata che si combatte in Ucraina.
L’anarchismo rivoluzionario nella fase nichilista
Il filone principale di queste ultime analisi, che solo impropriamente e molto riduttivamente possiamo definire di attualità politica, è quello che ci porta ai due scritti contro i quali hanno polemizzato i nostri ultimi interlocutori. In occasione della prima elezione di Trump abbiamo abbozzato un’ipotesi di massima, ancora oggi a mio avviso piuttosto buona per descrivere il presente: siamo di fronte a una fase che definiamo «crisi della globalizzazione», la cosiddetta ondata reazionaria che tanto spaventa i benpensanti di sinistra (Trump, Putin, Orban, i dazi, l’irrigidimento dei mercati, il razzismo e la chiusura delle frontiere) è espressione fenomenica di questa crisi; questa crisi è resa possibile dalle nuove tecnologie, le quali rendono relativamente più agile la produzione nelle economie sviluppate invertendo la dinamica creatasi durante la lunga stagione delle delocalizzazioni (nel frattempo anche i Paesi un tempo poveri sono diventati a capitalismo maturo, gli operai asiatici hanno cominciato a pretendere stipendi un po’ più decenti, ecc.); una parte del capitalismo occidentale dunque ha optato per il ritorno a casa propria degli investimenti, dandosi degli involucri politici (come il trumpismo) che facessero delle politiche (i dazi, per fare un esempio di recentissima attualità) atte allo scopo, mentre la vecchia èlite politica liberale è inorridita e ha chiamato alla resistenza.
Quello che ci premeva all’epoca e che mi preme tutt’ora ribadire è che in questo scontro tra la fazione sovranista e la fazione liberista della borghesia gli sfruttati non hanno amici. Prima ancora della guerra guerreggiata, noi già proponevamo il disfattismo rivoluzionario nella guerra mondiale ideologica tra sovranisti e liberisti. Prevedevamo che purtroppo gli sfruttati sarebbero rimasti estremamente confusi e che per molto tempo il clima generale sarebbe stato molto sfavorevole ai rivoluzionari. E che gli stessi militanti antagonisti si sarebbero lasciati incantare dalle sirene delle varie fazioni, come purtroppo è successo e sta ancora succedendo. (Cfr. Nazionalismoduepuntozero. Dodici ipotesi su robotica, crisi della globalizzazione e «ritorno» dello Stato-nazione, in “Vetriolo” n. 3, inverno 2019; d’ora in avanti verrà nominato con l’espressone le «dodici ipotesi»).
Il concetto di fase nichilista e il concetto di anarchismo rivoluzionario nascono qui.
La fase nichilista è la condizione in cui si trova la lotta di classe in questo momento. La lotta di classe non sparisce, ma viene rimossa, essa è inconsapevole, non cosciente, spesso derisa e maledetta, rinnegata dai suoi stessi attori. Ma non per questo scompare. La lotta di classe, per fare un parallelismo con la psicanalisi, viene rimossa, ma questo rimosso ritorna come una rimozione traumatica, continua a perturbare il sonno della pace sociale. Torna come sintomo, come nevrosi, come irrazionalismo di massa. La sua espressione principale per anni è stata nella forma sintomatica della resistenza di massa contro lo sviluppo scientifico.
L’anarchismo rivoluzionario è per certi aspetti un altro lato del problema, per altri aspetti è la soluzione (si spera) del problema. Si tratta di un approccio all’anarchismo all’interno del quale non si rifiuta aprioristicamente un atteggiamento strategico alle questioni sociali. Un anarchismo quindi capace di manovra, di progetto e di tattiche mutevoli atte alla realizzazione del proprio progetto. Questo avviene, come ha spiegato con una felice sintesi l’autore dell’omonimo articolo, attraverso il passaggio, nel nostro modo di agire, dall’azione per l’azione all’azione nella strategia. L’anarchismo rivoluzionario è quindi sia uno strumento all’interno della fase nichilista, che soffia sul fuoco della negazione, sia il suo superamento, perché all’interno della rivolta irrazionale interviene strumentalmente con un progetto razionale. Quindi non solo i due articoli andrebbero letti come complemento della storia teorica di “Vetriolo”, ma andrebbero anche letti in maniera complementare essi stessi.
Non voglio risultare pedante e rimproverare ai critici di «non aver studiato» – anzi li ringrazio per aver letto e commentato qualcosa di quello che abbiamo scritto. Semplicemente se non si tiene a mente questo percorso – nello specifico, che la fase nichilista era una delle «dodici ipotesi» del 2019 – possono generarsi fraintendimenti.
Per esempio, nel testo anonimo Alcune considerazioni critiche su “La fase nichilista” si afferma: «va detto che Vetriolo non dice nulla di nuovo, anzi arriva in ritardo rispetto a certe riflessioni teoriche prodotto a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta nell’ambito della critica radicale». Sinceramente la critica non mi tange. In primo luogo perché, come dicevo, non ho il vezzo dell’originalità. Non mi interessa dire delle cose originali, ma mi interessa cercare di comprendere le cose come stanno. In secondo luogo, perché essere paragonato alla critica radicale mi sembra un generoso complimento.
Nondimeno in questa affermazione c’è un equivoco innanzitutto storico. Oggi abbiamo a che fare con delle differenze fondamentali in ordine di dimensione e di collocazione politica del fenomeno.
Di dimensioni, perché il nuovo proletariato eccedente conta i suoi membri nell’ordine di centinaia di milioni, forse di miliardi di esseri umani: quello che succede a Gaza è (almeno sul piano quantitativo) molto di più di una rivolta del ghetto e della sua feroce repressione poliziesca. Di collocazione politica, perché per quanto lo si possa negare con le parole è evidente che quel tipo di rivolte di cui parla l’anonimo interlocutore avevano in qualche modo qualcosa da dire a un certo mondo di sinistra: un riot di neri, la rivolta di Stonewall ci parla di qualcosa che il mondo della sinistra radicale è in fondo disponibile ad ascoltare (fino al punto di trasformarsi in sinistra delle minoranze); lo stesso ascolto quella sinistra non lo sa dare alla proteste no vax e antiscientiste. I malumori irrazionali della working class bianca, etero, ecc., (che in Occidente va a comporre la massa umana largamente maggioritaria dentro l’irrazionale dispiegarsi della lotta di classe sotto le vesti delle pulsioni nichiliste) sono anzi disprezzati da certi critici-radicali-universitari, e vengono regalati al consenso della destra.
Vi è poi una differenza economica e sociale impressionante rispetto alla seconda metà del Novecento: all’epoca l’economia era in espansione e le rivolte irrazionali, come ha efficacemente sintetizzato Bonanno, erano rivolte degli esclusi, espulsi dal circuito del benessere; oggi, viceversa, l’economia è in contrazione e gli esclusi stanno diventando la maggioranza, con la proletarizzazione delle cosiddette classi medie.
La fase nichilista di cui parliamo noi avviene in un contesto storico nel quale il dibattito pubblico è scisso fra la corrente sovranista e quella liberista del capitale, e oltretutto dove la scienza ha fatto passi giganteschi in termini di espulsione di forza lavoro, di controllo, di rimbecillimento. Il nostro anonimo interlocutore continua a ripetere che in quel che accade non c’è nessuna svolta, «ma è frutto di quella ristrutturazione permanente […] iniziata negli anni Settanta»; mi sembra una puntualizzazione sterile, perché di ogni fenomeno storico è dimostrabile la provenienza da un altro fenomeno storico del passato (peraltro contiene almeno un equivoco, dato che il compagno parla di «delocalizzazioni» mentre la fase nichilista di cui parliamo noi inizia appunto con la crisi della globalizzazione). Eppure negli anni Settanta – per favore compagni non prendiamoci per i fondelli – per quanto vi raccontavate di essere brutti, sporchi e cattivi, vi era comunque una geografia politica dentro la quale il partito comunista era meno peggio della democrazia cristiana e la democrazia cristiana era meno peggio dei neofascisti. Nella fase nichilista, viceversa, non esistono più i partiti riformisti di classe.
Oggi viviamo in un contesto storico nel quale, per fare un esempio perturbante, sulla guerra in Ucraina ci ritroviamo più vicini al programma di Alternative für Deutschland che a quello dei socialdemocratici. O per fare un esempio ancora più sconvolgente, oggi siamo nell’epoca nella quale il più grande sciopero degli ultimi anni nell’industria dell’automobile nordamericana – uno sciopero a oltranza, a scacchiera, distribuito sul territorio colpendo stabilimenti che producono componenti fondamentali, riscoprendo dunque il vecchio sciopero fordista ma in una dinamica di distribuzione e parcellizzazione della produzione – viene diretto e guidato alla vittoria contro i capitalisti da un gruppo di operai che, pochi mesi dopo, durante la campagna elettorale, darà vita a un comitato dal nome eloquente di «Worker for Trump». Questa è la fase nichilista.
Il nichilismo è un metodo, non è una cosa (e il populismo è suo papà)
Ma c’è un’altra differenza tra la proposta di “Vetriolo” e quella di precedenti teorici delle rivolte irrazionali: per decenni vari, differenti e per alcuni versi opposti contesti teorici quali la critica radicale, il complesso teorico Focault-Agamben, il postmodernismo, buona parte dell’insurrezionalismo in qualche modo li ritroviamo accumunati dal fatto di aver trascurato il momento del rovesciamento; concentrandosi sulla dissezione critica, sull’archeologia del dominio, sulla decostruzione, sull’azione da fare nel presente (il motto del «qui e ora»). Giustamente sfiancati da decenni di messa salmodiata sulle note di una versione banalizzata della dialettica hegelo-marxista, ci hanno precipitati più o meno consapevolmente in una sorta di criticismo infinito. Ovvero in una serie di filosofie sul metodo e mai sulla sostanza: il metodo della decostruzione, quello dell’archeologia del dominio, quello insurrezionale.
Se prendiamo il famigerato motto focaultiano per cui «Là dove c’è potere c’è resistenza e […] tuttavia, o piuttosto proprio per questo, essa non è mai in posizione di esteriorità rispetto al potere. [… I rapporti di potere] non possono esistere che in funzione di una molteplicità di punti di resistenza, i quali svolgono, nelle relazioni di potere, il ruolo di avversario, di bersaglio, d’appoggio, di sporgenza per una presa» (Cfr. Archeologia del sapere), ci rendiamo conto che in questa filosofia la rivoluzione è impossibile: potere e resistenza sono due schemi trascendentali di quella sorta di gigantesco Io kantiano che è diventata per queste teorie la coscienza collettiva, quindi non ci sarà mai la «vittoria» della resistenza e la distruzione del potere, in questa proposta filosofica e politica essi sono co-necessari.
Eppure, anche se prendiamo il primo numero di una rivista che ha profondamente influenzato la nostra storia come «Anarchismo» vi possiamo leggere un articolo di Alfredo Bonanno, si potrebbe dire di presentazione e di programma, nel quale fra le altre cose si afferma: «L’uso della ragione, donde è possibile parlare di materialismo, può essere fatto in senso dogmatico (assolutista) e in senso critico (non dialettico). In quest’ultimo senso, che è poi quello che ci interessa, possiamo dirci razionalisti, non dialettici, critici, pluralisti, volontaristi; in quest’ultimo senso la volontà (irrazionale) coglie il momento positivo della ragione (razionale) e determina la forma storica (materiale), senza esservi costretta da un modello prefissato (dialettico)» (Cfr. A.M. Bonanno, Crisi economica e possibilità rivoluzionarie, in «Anarchismo» n. 1, 1975, p. 4).
Se all’epoca queste affermazioni hanno aiutato il movimento anarchico a evadere dal conformismo di una cattiva dialettica, oggi dobbiamo fare lo sforzo di evadere paradossalmente dal conformismo neo-kantiano nel quale siamo arretrati. I discorsi della nostra area sono troppo spesso panegirici sui presupposti trascendentali dei modi di intervenire sulle cose, senza mai parlare della Cosa stessa.
Mi spiego con degli esempi concreti: l’ipotesi organizzativa tracciata negli anni da «Anarchismo» (nuclei di base, gruppi d’affinità, organizzazione informale) virtualmente può essere utile per la lotta a Comiso degli anni Ottanta, come può essere utile per una campagna per convincere la NATO a intervenire direttamente in Ucraina o viceversa per una campagna per sostenere il disfattismo rivoluzionario in Ucraina. Da solo quel pacchetto non ha contenuti, ci parla solo di metodologia (si può ovviamente muovere le stesse obiezioni all’organizzazione proposta da Cospito in Quale internazionale?). Questo accade perché quella proposta è una proposta trascendentale di metodo (può essere applicata a diverse situazioni).
Al contrario proporre un discorso nel quale si affermi che – per esempio – quando c’è una guerra fra Paesi capitalisti bisogna disertare il fronte, lottare contro ogni Stato a partire dal proprio, per trasformare la sconfitta del proprio Stato in una chance rivoluzionaria e poi, dentro questa rivoluzione, lottare per il comunismo in economia e l’anarchia politica, si propone un discorso nel quale si intravedono percorsi per rovesciare la realtà (il metodo non scompare, ma è utilizzato per trasformare le cose; non è un metodo della ragion pura, ma è sporcato di realtà).
Su questa questione mi ritrovo d’accordo col nostro critico e mi dispiace se non mi sono spiegato bene. Se la domanda fondamentale che ci pone è: «Ma le rivolte e la fase nichilista di cui Vetriolo parla, questa “passione degli sfruttati” è semplicemente una reazione di massa alla svolta tecnototalitaria o una negazione radicale di un’organizzazione sociale di cui lo sviluppo scientifico, per quanto pervasivo nelle sue applicazioni, rimane un mezzo e non un fine in sé, volta alla messa a valore, e dunque al controllo e alla prevedibilità, di ogni aspetto della vita dei proletari?» Pure io «opterei per la seconda ipotesi», a patto che non scambiamo il nostro desiderio con la realtà, ovvero cercando un modo per fare sì che «il momento della rivolta senza senso diventa [diventi, purtroppo il condizionale è d’obbligo!] il momento della disarticolazione di questa organizzazione nei suoi spazi, tempi, mezzi riti e miti».
Perché questo nostro intervento possa almeno un minimo contribuire in tale direzione, bisogna però passare dal discorso sul metodo all’utilizzo del metodo per cambiare la sostanza. D’altro canto, ha ragione il nostro critico, anche la scienza è un metodo del capitale e non certo una potenza ontologica come nell’ultimo Heidegger (e sembra, anche nell’ultimo Bonanno di «Negazine»).
Questo stesso discorso va applicato, più in grande, alla categoria di nichilismo e alla fase nichilista che viviamo in questa stagione storica. Il nichilismo non è una Cosa, ma è un metodo. Il più importante esempio di movimento nichilista – quello dal quale, per forza di importanza e suggestione storica, tutti gli altri bene o male prendono ispirazione – lo troviamo nell’impero zarista nella seconda metà dell’Ottocento.
Voglio tornarci ancora una volta su questa storia, perché mi aiuta a rispondere alle critiche di panopticon sull’utilizzo del termine «populismo» per il quale ci siamo presi un rimprovero nella loro introduzione critica. Il movimento di cui sto trattando attraversa almeno tre generazioni. La prima generazione era composta da giovani delle classi colte ed europeizzate i quali, col motto di «andare al popolo» (i populisti, appunto) si riversarono nei villaggi desolati per spiegare ai servi come sarebbe stato meglio vivere senza padroni, senza Zar, proprietari essi stessi dei mezzi di produzione, decidendo le questioni fondamentali in assemblee democratiche territoriali. Il risultato di questo tentativo utopico fu che una buona parte di quei giovani idealisti finirono ammazzati dagli stessi contadini, linciati in dei pogrom istigati dal clero, additati come agenti del demonio.
Per reazione di fronte a questa catastrofe nacque il nichilismo. Ora non bisognava più parlare al popolo, ma esprimere la propria rabbia nichilista con bombe e attentati. Il più famoso di questi fu l’uccisione dello Zar Alessandro II, avvenuta il 13 marzo 1881 a San Pietroburgo. Paradossalmente, proprio coloro che meno erano interessati a parlare al popolo ottennero il massimo del consenso popolare. Quella generazione venne perlopiù distrutta dalla repressione, ma generò come seguito politico la nascita del socialismo rivoluzionario.
I socialisti rivoluzionari russi (la terza generazione) furono un partito terrorista di massa (oggi mi verrebbe di paragonarlo mutatis mutandi ad Hamas), socialista, non marxista, a base contadina; più che una sintesi, una vera e propria sommatoria di populismo più nichilismo. Il loro consenso fu talmente vasto che furono loro a prendere per qualche mese il potere, dopo la rivoluzione del marzo 1917 (cosiddetta rivoluzione di febbraio). Il loro metodo rimase l’azione diretta rivoluzionaria e le esecuzioni politiche anche dopo la rivoluzione; nel loro seno matura l’attentatrice che, ancora nell’agosto del 1918, cercò di assassinare Lenin accusato di aver tradito la rivoluzione democratica socialista con mezzi autoritari.
Ai compagni di panopticon io vorrei dire questo. Noi potremmo passare il nostro tempo a scrivere delle riviste anarco-bordighiste, con delle categorie classiste e internazionaliste perfettamente coerenti. Sicuramente ci troveremmo d’accordo su tutto e potremmo anche farle insieme queste pubblicazioni. Sono sicuro che ci divertiremmo un casino, potrebbe essere un’alternativa più salutare dell’LSD. Ma questo non ci aiuterebbe a spostare di un millimetro la realtà.
Quando dico che bisogna prestare attenzione ai movimenti populisti, se mi si consente un parallelismo storico tanto forzato quanto grandioso, io intendo che dovremmo spingere l’attuale populismo verso i suoi fallimenti, per aiutare la nascita di un nuovo movimento nichilista, prodromo del socialismo rivoluzionario del ventunesimo secolo. Sempre mia nonna diceva che il pane si fa con la farina che si ha, se vogliamo rivoluzionare la realtà dobbiamo partire, appunto, dalla realtà. In questo momento il populismo/nichilismo è l’espressione irrazionale e non cosciente (ovvero, incosciente!) della lotta di classe. L’unico modo in cui essa si esprime a livello di massa in Occidente.
Volando un po’ più bassi, panopticon trascura la situazione particolare italiana nell’anno 2022, quando uscì quell’articolo. Avevamo all’epoca il governo di Mario Draghi, ovvero il grande esperimento controrivoluzionario (riuscito, purtroppo) del Governo di Unità Nazionale. Bisogna capire che il governo di Unità Nazionale è stato molto di più di un semplice governo di grossa coalizione alla tedesca. Non era solo l’unità dei partiti politici in parlamento, ma vedeva al suo interno esponenti di Confindustria e dei sindacati, ambasciatori, economisti, scienziati e persino generali dell’esercito, aveva il consenso dell’UE, della NATO, del Vaticano. Con le forze esterne al parlamento che davano esse stesse un contributo all’Unità Nazionale sospendendo gli scioperi (nel caso dei sindacati), sospendendo le manifestazioni di piazza per evitare il contagio del virus (nel caso delle aree antagoniste). Si tratta del governo che ha gestito l’uscita dall’emergenza pandemica manganellando gli operai, decuplicando gli infortuni sul lavoro, togliendo il blocco ai licenziamenti che era stato introdotto nelle leggi emergenziali precedenti, traghettando l’Italia nella guerra in Ucraina e mettendo Alfredo Cospito in 41 bis.
Il governo di Unità Nazionale di Mario Draghi è qualcosa che merita di essere studiato meglio, dedicandogli una ricerca apposita. Credo che questa formula politica potrebbe venire replicata nei regimi democratici in crisi: in effetti dalla Germania all’Inghilterra alla Francia sempre più la borghesia cerca di risolvere la propria incapacità di governare con esperimenti di fronti parlamentari allargati; anche se il governo di Unità Nazionale rappresenta un passo ulteriore rispetto a queste formule, è unità sociale e non solo parlamentare, presto il modello italiano potrebbe ispirare questi Paesi e la Germania ho la sensazione sia la candidata numero 1 su questa strada.
Nel 2022 il fronte popolare esisteva già, esso era il governo del Paese. Non era solo popolare, era un fronte popolare e delle élite, clericale e scientifico, industriale e sindacale, civile e militare. Pertanto stare col «populismo» per noi significava non certo costituire un fronte nazionalpopolare, che esisteva già e stava al governo, ma cercare qualche compagno di viaggio tra quei pochi raminghi fuori da quel maledetto fronte. Questa era quel poco di farina di cui disponevamo per il nostro pane.
Il comunismo non è la socializzazione delle mutande e dei calzini, ma “a ognuno secondo la sua taglia”
Tornando alla nichilismo per antonomasia, quello russo. I socialisti rivoluzionari russi in fondo, a dispetto del nome e a dispetto delle pratiche (a proposito del luogo comune insurrezionalista per cui le pratiche da sole bastano a distinguere il grano dal loglio – purtroppo non è così), furono dei riformisti. Lo furono in principio e lo furono anche alla fine. Anzi, peggio, alla fine furono dei traditori: preso il potere proseguirono la guerra al fianco delle potenze dell’Intesa, sfiancando il Paese, spingendolo a una nuova rivoluzione.
Che significa tutto questo? Significa che il metodo nichilista da solo non basta. Bisogna capire quale è il nostro fine. Così siamo giunti finalmente alla questione del comunismo.
Per proseguire la trattazione mi faccio ora aiutare dalle critiche che abbiamo ricevuto da Juan Sorroche nei tre suoi preziosi articoli. Nel primo di questi Juan scrive che «nell’individualismo anarchico economico» avviene che «sia il prodotto che gli strumenti di lavoro rimangono all’individuo, e solo lui decide se metterli in comune con quanti si associano all’interno di gruppi di affinità», pertanto «è il produttore che gestisce tutto, senza nessun intermediario», a differenza che nel comunismo: «l’individualismo anarchico è contrario al comunismo, e vi scorge un pericolo autoritario».
Bisogna dire, a onor del vero, che il comunismo anarchico è sempre stato fondato sul concetto di volontarietà. Da parte anarchica è sempre parlato, sin dalla Prima Internazionale, di associazione volontaria dei produttori. E ancora oggi, dopo secoli, la versione italiana dell’inno L’Internazionale (che genericamente viene considerata una canzone dei partiti politici comunista e socialista) per la verità nella seconda parte recita «fratelli tutti, e se vogliamo, nella famiglia del lavor».
Dunque la volontarietà è alla base di ogni autentico comunismo, quando questa è stata superata con le collettivizzazioni forzate (come in Unione Sovietica), ogni residuo barlume di economia comunista si è spento e sono state riprodotte le dinamiche del capitalismo: salario, governo della forza lavoro, turni di lavoro, espropriazione di plusvalore, ecc.
Ma non voglio aggirare la critica di Juan con una puntualizzazione formale (per quanto, su questo argomento, la forma è quanto mai sostanza!). Veniamo all’essenza della questione. Cosa significa comunismo? Quella comunista è l’economia dove le persone producono secondo le loro possibilità e ricevono secondo i loro bisogni. Ancora una volta dobbiamo distinguere il mezzo dal fine: persino la proprietà collettiva è un mezzo in questa definizione, il fine è che ognuno riceva secondo i propri bisogni. Anche comunisti autoritari come Marx ed Engels affermano nel Manifesto che è una calunnia quella secondo la quale i comunisti vorrebbero l’abolizione della proprietà privata; in verità, essi vogliono semplicemente l’abolizione dei rapporti di proprietà privata capitalistici.
Detto in parole semplici, il comunismo non è una comune hippy dove tutto è di tutti, pure le mutande e i calzini (probabilmente sporchi, perché nessuno ha voglia di lavorare). Il comunismo non è che una compagna viene a casa mia, mi prende in prestito un libro che mi aveva regalato nonna e poi lo spedisce a un carcerato (che poi avevi detto che me ne avresti rubato un altro, sto ancora aspettando). Comunismo è che la tipografia e la fabbrica di biancheria producono quello che serve e le persone se lo prendono in base ai loro gusti, bisogni… e misure. E ovviamente non esisteranno le galere. Naturalmente, affinché tutti abbiano il libro che vogliono, le mutande che gli stanno bene e i calzini che non puzzano occorre che ciascuno, secondo le proprie possibilità, lavori in tipografia, distribuisca le mutande o lavi i calzini.
L’economia comunista è la più naturale, essa già avviene da sempre nella riproduzione della specie: un neonato ha solo bisogni e riceve unicamente, e così via nelle generazioni successive, la «restituzione» non avviene nemmeno nello stesso spazio-tempo. Ma l’economia comunista è anche la più umana, il più alto gradino etico raggiunto dalla cultura economica del genere umano (una nota per panopticon, nel mio articolo con «cultura» intendevo tutto ciò che non è natura, quindi la polemica era coi primitivismi, perché a mio avviso serviranno ancora le lavatrici e le tipografie per soddisfare i nostri bisogni, per rimanere nell’esempio di cui sopra; forse c’è un errore nella traduzione perché su questo avete completamente frainteso).
Ora paragoniamo questo modo veramente umano di vivere insieme con la proposta di economia individualista anarchica suggerita da Juan sulle tracce di E. Armand. Per farlo utilizzerò una di quelle odiose categorie di cui si riempiono la bocca gli attivisti oggigiorno, a loro volta imboccati dall’immondizia culturale delle università nordamericane; la categoria di «abilismo». Peraltro una categoria utilizzata per giustificare, negli scorsi anni, le leggi liberticide ai tempi del Covid-19. Perché avere paura della morte è cosa sana, smettere di vivere per paura di morire è patologico, ma pretendere che tutti smettano di vivere per la propria paura di morire, questo è odioso. Davvero una gestione stalinista, verrebbe da dire una collettivizzazione forzata dei problemi di salute di alcuni a danno della libertà di tutti. A dimostrazione di quanto dicevo all’inizio, ovvero che le narrazioni sulle nuove oppressioni di tipo non classista derivano molto di più dall’antico tradimento stalinista-maoista della lotta di classe piuttosto che da posizioni libertarie (con il correlato linguistico di decolonizzazione, fronti di liberazione… nazionale/animale/sessuale/ecc.).
Ma lasciamo perdere tutto questo e prendiamo per buona la categoria di abilismo, così ci facciamo capire anche dai giovani attivisti di oggigiorno. In una economia comunista, dove tutti ricevono secondo i loro bisogni, anche chi non ha (per età, per attitudine, per disabilità) la possibilità di produrre il necessario per vivere, riceve comunque quanto gli abbisogna. In senso stretto, non esisterà più nemmeno la disabilità, perché ciascuno è in grado di dare qualcosa alla collettività e non necessariamente su un terreno materiale (può raccontare storie, donarci un sorriso, dare consigli, può dare un contributo culturale, ecc.). Ecco perché è solo la questione di classe a illuminare di più chiara colorazione e quindi a risolvere anche le altre oppressioni: in questo caso, semplicemente, la linea di faglia dicotomica intorno alla disabilità scompare, perché nel comunismo tutti sono abili a dare quello che possono dare e ciascuno riceve in base al bisogno, non in base alla propria abilità (lo stesso ragionamento si applichi alle altre oppressioni).
Prendiamo ora la proposta economica individualista anarchica. Dove ognuno produce per sé e si associa alla bisogna. Un disabile, un bambino, un anziano in questa economia semplicemente muore. Oppure deve ridursi alla carità, deve sperare nel dono degli individui che egoisticamente godono nel donare. Non si può avere il diritto di stare antipatici a tutti, di non avere amici. O forse, per evitare questa catastrofe umanitaria, si andranno necessariamente a riprodurre delle istituzioni: per esempio un questua di compagni che chiedono benefit per i problemi sociali, che si fanno essi stessi agenti di welfare, riproducendo lo Stato e il fisco. Naturalmente si lavorerà tutti molto di più, perché lavorare in maniera associata notoriamente riduce le tempistiche del lavoro. E ancora – giacché nessuno è in grado di produrre tutto – dopo il lavoro si dovrà andare al mercato a scambiare i prodotti, a litigare sul loro valore, insomma si ritornerebbe schiavi della tirannia della domanda e dell’offerta.
Io credo che questa proposta sia una bestialità; di più io credo che questa sia già la barbarie in cui viviamo oggi. L’individualismo economico c’è già, si chiama capitalismo. Peraltro anche questo capitalismo utopico, nel quale non ci sono lavoratori dipendenti, durerebbe cinque minuti, perché chi non riesce a sopravvivere ben presto dovrà vendersi a chi gli offre qualcosa.
Allora aveva proprio ragione Malatesta: l’unico modo per avere l’individualismo, un individualismo autenticamente anarchico, dove ogni individuo ha i mezzi disponibili in un’epoca storica per realizzarsi, è soltanto all’interno di un’economia comunista.
Ovvero ha ragione Juan: sì occorre il comunismo con l’individualismo, ma bisogna specificare la dinamica di questa comunione: è la premessa realizzazione dei bisogni di tutti che permette il conseguente libero sviluppo individuale. Cioè, detto in parole semplici, non è necessaria la socializzazione di tutta la vita produttiva, questa stessa pratica di per sé è ancora solo un mezzo; quello che è necessario è che ognuno abbia quanto gli abbisogna; per raggiungere questo fine altamente etico a mio avviso si possono anche cercare una pluralità di percorsi: aziende familiari e cooperative, comuni e socializzazioni, mi vanno benissimo anche i mezzi di produzione individuale che piacciono più a Juan. Non mi fossilizzerei dogmaticamente su questi che sono solo strumenti. Beninteso, però, che il fine deve essere la soddisfazione dei bisogni di ciascuno, se alcuni di questi strumenti si dimostreranno un intralcio alla realizzazione del fine i rivoluzionari devono avere la prepotenza necessaria a spazzarli via.
La tortura continua (con un escursus di filosofia medievale)
Per riuscire a scacciare anche l’ultimo lettore rimasto, adesso mi metto pure ad aprire un parentesi niente meno che di filosofia medievale. La questione d’altronde è interessantissima: la teoria delle essenze. Da un po’ di tempo nei circoli politicamente corretti va di moda dire di qualcuno che è un «essenzialista» un po’ come nel medioevo si dava dell’epicureo, un sinonimo di stronzo. Dobbiamo questa degradazione dell’essenza al motto esistenzialista di Sarte: l’esistenza precede l’essenza.
Ma allora, dobbiamo preoccuparci se ci danno degli «essenzialisti»?
Dipende. Da cosa dipenda ci può aiutare a capirlo, appunto, la filosofia medievale. Nel violento scontro tra tomisti e francescani verso la fine del XIII secolo – segnatamente nelle figure di Egidio Romano ed Enrico di Gand – i temi di essenza e sostanza sono stati abbondantemente agitati, armati come una clava tra le due fazioni.
La posizione dei neoplatonici, dei francescani, degli agostiniani, insomma di Enrico di Gand è che tra essenza e sostanza, c’è una distinzione/identità intenzionale. Significa che Dio pensa eternamente le essenze e che con la sua volontà, intenzionalmente, le fa esistere, cioè dona ad alcune di esse, per un certo tempo, l’essere, le riempie di sostanza. Il rimando è ovviamente a Platone, le essenze sono le Idee (con l’aggiunta che queste sono pensate eternamente da Dio) e il creato sono le essenze dotate, intenzionalmente, di sostanza.
La risposta dei tomisti, invece, per intervento di Egidio Romano, è che tra essenza e sostanza c’è un’identità reale. Significa che esse non sono pensate eternamente da Dio, ma radicalmente create dal nulla (accusando gli essenzialisti platonici di negare il creazionismo); e che quando sono infine create, le cose sono immediatamente composte di essenza ed esistenza. Essenza e sostanza sono sinonimi. Qui il rimando è a un Aristotele riformato.
Perché tutta questa rottura di coglioni? Perché, lo devo confessare, non ce la faccio più a vivere nell’ombra, devo fare coming out… ebbene si, io sono un essenzialista. E pazienza se verrò crocifisso in sala mensa come Fantozzi, pestato dagli assistenti professori precari e preso a cancelletti in faccia dagli attivisti della cancel culture. Il problema è che questi professorini mistificano le cose per mettere nello stesso calderone tutti coloro che non la pensano come loro (Riduci la realtà alla lotta di classe? Sei tacciato di essenzialismo di classe. Vuoi difendere la natura? Sei accusato di bioessenzialismo, ecc., ecc).
Allora spieghiamoci bene.
Io non sono un essenzialista platonico o agostiniano e meno che mai francescano. Sono un essenzialista nel senso materialista del termine: per me l’essenza delle cose non è una misteriosa loro recondita verità, ma è la loro sostanza.
D’altronde questa critica delle essenze e delle sostanze di cui tanto vanto si fa il pensiero debole contemporaneo, proviene da un percorso più antico – più che compatibile, direi proprio essenziale – del pensiero dominante. Nel suo Dialogo sopra i massimi sistemi Galileo Galilei conduce un attacco spietato contro le sostanze naturali. Sostiene il grande scienziato che «o noi vogliamo specolando tentar di penetrar l’essenza vera e intrinseca delle sustanze naturali; o noi vogliamo contentarci di venir in notizia d’alcune loro affezioni» . Ma la conoscenza dell’essenza delle sostanze naturali viene dichiarata impossibile tanto «nelle prossime sustanze elementari che nelle remotissime e celesti», mentre, al contrario, se noi «vorremmo fermarci nell’apprensione di alcune affezioni, non mi par che sia da desperar di poter conseguirle anco ne i corpi lontanissimi da noi, non meno che nei prossimi» . Non dobbiamo quindi cercare l’essenza della natura, ma accontentarci di studiarne «il luogo, il moto, la figura, la grandezza». (Cfr. Opere, vol. V, p. 187).
Insomma per la scienza moderna bisogna rinunciare a conoscere le essenze, accontentandoci di conoscere criteri superficiali di tipo quantitativo intorno alle cose. Si tratta di una posizione profondamente anti-materialista, io definisco quello della scienza moderna un «anti-materialismo scientifico»; non a caso l’apice della scienza moderna è il nucleare, vero e proprio orrore contro la materia fino ai suoi elementi più sacri e inviolabili (l’atomo di Democrito).
Quindi la critica della conoscibilità qualitativa delle sostanze è un pensiero fondativo della scienza moderna. Un certo anti-essenzialismo dei movimenti contemporanei è ben compatibile con questo pensiero dominante.
Con Juan io credo che ci sia un fraintendimento di questo tipo. Juan sembra essere tutt’altro che un essenzialista (potrei sbagliarmi, ma il suo anarchismo non sistemico come lo definisce lascia apparentemente questa sensazione di alterità rispetto a ciò che è metafisico, sostanziale, sistematico, essenziale). Sembra dirci talvolta – mi perdoni la banalizzazione – che ci sono dei gran bravi compagni individualisti e ci sono dei riformisti anche tra i comunisti anarchici. Ma questa cosa noi non l’abbiamo mai messa in discussione! Noi diciamo che una certa posizione teorica (indifferenza verso l’analisi della realtà, disprezzo della lotta di classe, orrore verso ogni forma di pensiero strategico, individualismo intellettuale e bibliotecario, regressione del proprio intervento a problemi esclusivamente interni del movimento) conduca essenzialmente al riformismo e alla desistenza.
Non si tratta di seguire un criterio di «maggioranza» come scrive Juan (peraltro oggi la maggioranza dei compagni è tutt’altro che anarco-comunista-insurrezionalista, magari!), ma di sostenere, dal nostro punto di vista, che ovviamente è del tutto discutibile, la natura riformista di certe posizioni. Che esse sono sostanzialiamente riformiste – al di là dei casi particolari, al di là del criterio quantitativo; non conta se esse siano maggioritarie o meno, la critica è più profonda, è riformista il nocciolo essenziale di quelle posizioni.
Torniamo quindi ad Armand. Il problema qui non è che Armand abbia detto sia delle cose fighe sia delle cose riformiste. La questione è che l’autore dell’articolo L’anarchismo rivoluzionario contro la desistenza sostiene che l’approdo riformista sia in qualche modo essenziale, conseguente alle premesse teoriche del suo pensiero, sia la sostanza del pensiero di Armand.
Scrive Juan:
«E. Armand lo scrive molto chiaro: non esclude, come vediamo nella frase sopra, né il rivoluzionario né “l’attentato” e “l’attentatore individuale”, né “l’espediente ‘illegalista’” né qualsiasi mezzo-metodo, anche violento, come insurrezioni e rivoluzioni, che sia consono alla prospettiva dell’individualismo anarchico. Certo, sì!, include anche il pacifismo, “la resistenza passiva” come “tattiche rivoluzionarie”. E anche crede nelle rivoluzioni pacifiche; io penso che le preferisce, con l’astensionismo. Con l’educazionismo, che ogni individualità prenda coscienza libera e autonoma e che sarà così consapevole per affrontare una rivoluzione di braccia incrociate generale e lo Stato e qualsiasi autoritarismo di fronte a ciò sarà più incapace di affrontare. Ma attenzione! Perché include tutte queste cose nell’insieme della prospettiva dell’individualismo anarchico. Certo ha la sua preferenza, come le abbiamo tutti».
In realtà stiamo dicendo quasi la stessa cosa. Quello che si sostiene in più nell’articolo di “Vetriolo” è che le posizioni pacifiste, educazioniste, ecc., sono essenziali, sono la sostanza più intima di un certo modo di intendere l’individualismo. Ma forse è proprio l’espressione «individualismo» a portarci fuori strada. A noi l’individualismo piace. Poiché in fondo il vero individualismo lo si può raggiungere solo in un’economia dove ciascuno ha secondo i propri bisogni, oltretutto da sempre l’azione diretta individuale e la propaganda col fatto sono pratiche dei comunisti anarchici. Insomma come diceva Malatesta, tutti gli anarchici sono comunisti e individualisti. Il nostro vero obbiettivo polemico era (e rimane) contro l’educazionismo dei nostri giorni, contro chi si dice troppo individualista per parlare di rivoluzione (finendo dialetticamente per ritrovarsi riformista).
Stirner padre del sindacalismo
Scrive ancora Juan, nel suo contributo più recente, parlando di desistenza e resa interclassista: «Questo è successo e succede solo esclusivamente allo sviluppo dell’individualismo anarchico?». Non è forse vero che larga parte della desistenza «non arrivi soprattutto dal comunismo-anarchico rivoluzionario?», «Oppure dall’anarchismo-sindacalismo, anch’esso in gran parte comunista rivoluzionario?».
Il nocciolo della questione l’ho affrontato nel precedente paragrafo: noi non diciamo che tutti i comunisti siano rivoluzionari e tutti gli individualisti riformisti, noi diciamo che essenzialmente riformiste sono le traiettorie fondamentali di certe posizioni. Qui voglio soffermarmi su quello che apparentemente sembrerà un dettaglio. L’anarco-sindacalismo, secondo Juan, sarebbe in gran parte comunista. Sembrerà un dettaglio, ma credo che affrontando questo argomento potremmo sciorinare meglio la questione dell’individualismo, dell’egoismo stirneriano, e del comunismo malatestiano cosiddetto volontaristico. Infatti io ritengo che il sindacalismo rivoluzionario in generale (non solo anarchico, penso per esempio a Sorel) sia una derivazione diretta del pensiero di Max Stirner e abbia poco a che fare col comunismo.
Che cos’è infatti un sindacato se non una stirneriana unione degli egoisti? I lavoratori nel sindacato si associano in quanto individui, chiedono al sindacato dei miglioramenti economici specifici, rinnegano la tessera quando questa diventa deteriore per i propri interessi. Precisamente la fluidità organizzativa stirneriana. Il sindacato è necessariamente portato all’accomodamento, al compromesso col padrone, perché il sindacato deve poter offrire all’individuo egoista che vi aderisce un beneficio tangibile.
Certo se Juan ha in mente la CNT, legittimamente visto l’importanza della vicenda storica, la cosa può portarci fuori strada. La complessa organizzazione CNT-FAI, infatti, proprio in virtù del successo che ha avuto, è stata qualcosa di più di una semplice organizzazione anarco-sindacalista. Essa è stata nei momenti migliori il soggetto collettivo dell’insurrezione, nel linguaggio marxista rivoluzionario potremmo dire che è stata «il partito della rivoluzione», quindi è diventata un soggetto politico che ha aderito al fronte popolare contro il pericolo fascista, quindi ha ceduto al frontismo e all’interclassismo, tradendo infine la rivoluzione e gli stessi principi anarchici (accettando per esempio dei ministeri).
Se noi però ci spostiamo in Italia vediamo come per esempio l’Unione Sindacale Italiana sin dal nome proprio di «Unione» richiami la proposta organizzativa stirneriana. Non è solo una suggestione: individualisti erano la gran parte della prima generazione di anarco-sindacalisti italiani come Alceste de Ambris, Filippo Corridoni, Michele Bianchi, Tullio Masotti, tutti espulsi a causa delle loro sciagurate posizioni interventiste durante la prima guerra mondiale (alcuni di loro diventeranno fascisti, de Ambris è noto per il contributo costituzionale dato all’avventura dannunziana a Fiume). Solo con la generazione di Borghi e Meschi l’USI riconquisterà una posizione coerentemente internazionalista e sarà la protagonista principale in termini di conflittualità durante il biennio rosso.
Ora se noi andiamo a leggere il capitolo che Stirner dedica alla questione operaia nella sua opera L’Unico e la sua proprietà possiamo scorgere degli automatismi che, sebbene ante litteram, hanno tutti i caratteri del sindacalismo rivoluzionario. Secondo Stirner se gli operai avessero una autentica consapevolezza dei loro bisogni egoistici distruggerebbero lo sfruttamento e non ci sarebbero più padroni. Questo non solo confuta la calunnia marxista di Stirner quale pensatore borghese, ma allo stesso tempo ci mostra quanto Stirner sia il padre di un certo modo di intendere il sindacalismo: l’idea che la consapevolezza egoistica immediata sia da sola causa sufficiente per l’emancipazione. Nel sindacalismo rivoluzionario questa idea porta al corollario che l’organizzazione immediata fondata sui bisogni egoistici (organizzazione minima, con meno struttura possibile), in una parola, il sindacato anarchico, da sola sia sufficiente per scatenare la rivoluzione.
Malatesta, com’è noto, dubitava di questo pregiudizio. L’organizzazione sindacale egoistica avrebbe portato non alla rivoluzione, ma all’accomodamento su linee di classe basate sulla categoria, sul territorio, sul singolo stabilimento e la singola azienda. Notoriamente per Malatesta il sindacato era necessario, ma non sufficiente. All’organizzazione sindacale (che asseconda il bisogno egoista, individualista, del lavoratore) occorre affiancare l’organizzazione insurrezionalista dei comunisti anarchici (il cosiddetto dualismo organizzativo): quest’ultima non si basa sui bisogni egoistici, ma sugli ideali, sulla volontà dei suoi partecipanti. Cioè sul fatto che i compagni che ne fanno parte sono animati da una tensione che trascende il loro egoismo, una tensione che li porta al sacrificio, a sopportare la fame, il carcere, la morte. Insomma c’è l’organizzazione della necessità (sindacato) e c’è l’organizzazione della volontà (Malatesta la chiamava, pensate un po’, partito).
Notoriamente, uno stirneriano ortodosso ribatterà a questi argomenti che anche queste passioni sono passioni egoistiche; chiunque fa qualcosa, anche chi si sacrifica, ci insegna Stirner, in realtà lo fa per sé. Se questo in astratto è vero, affermarlo però è anche inutile. Anche il carabiniere, il prete o il maniaco sessuale di via Togliatti che si apre l’accappatoio e fa vedere i gioielli di famiglia ai passanti sono egoisti in senso stirneriano. Tutti lo siamo. La scoperta di questa verità non ci fa fare un passo in avanti verso una società finalmente libera, in cui non ci sono più né preti né carabinieri, e dove anche il maniaco di via Togliatti riceve finalmente secondo i propri bisogni.
Quindi il comunismo anarchico malatestiano, tutt’altro che marxista, è davvero un movimento idealista nel senso migliore del termine. Esso in qualche modo mobilita i compagni che lo animano verso una passione che trascende la condizione materiale egoistica personale. In questo senso è insurrezionalista, perché è orientato al rovesciamento. In questo senso specifico è volontarista, organizza gli individui non per condizione ma per convinzione. Ed è il solo che per principio non può essere corrotto da derive riformiste (in quanto classista per definizione).
Juan scrive per esempio che «il concetto dell’anarchismo d’azione ha in sé gli antidoti al riformismo». Secondo me qui il compagno, nonostante affermi ripetutamente il contrario, rischia di nuovo di anteporre il metodo al fine. Azione per fare cosa? Per fare l’individualismo economico o per fare il comunismo economico? Per vincere una vertenza sindacale o per rovesciare il potere del padrone? Per convincere la NATO a tirare le bombe atomiche su Mosca o per distruggere la NATO? Insomma l’azione è comunista o individualista, internazionalista o interventista? Se Juan accetta un consiglio per l’elaborazione teorico-pratica che sta sviluppando, a mio avviso dovrebbe riempire di contenuti teleologici (quale è il nostro fine) questa sua proposta.
Non basta più definirci in base a quello che facciamo, la storia ha ricominciato a correre troppo veloce, occorre definirci in base al mondo che vogliamo. Per me l’anarchismo rivoluzionario dovrebbe essere classista, internazionalista e insurrezionalista; cioè orientato a un’ideale, a una lettura del presente e a un metodo. Nessuna di queste cose, prese da sole, sono sufficienti.
emmeffe
[Ricevuto via e-mail e pubblicato in https://lanemesi.noblogs.org/post/2025/10/21/sulle-solite-vecchie-amate-questioni-a-proposito-di-comunismo-e-individualismo-con-disimpegno-a-vista-sul-nichilismo/]