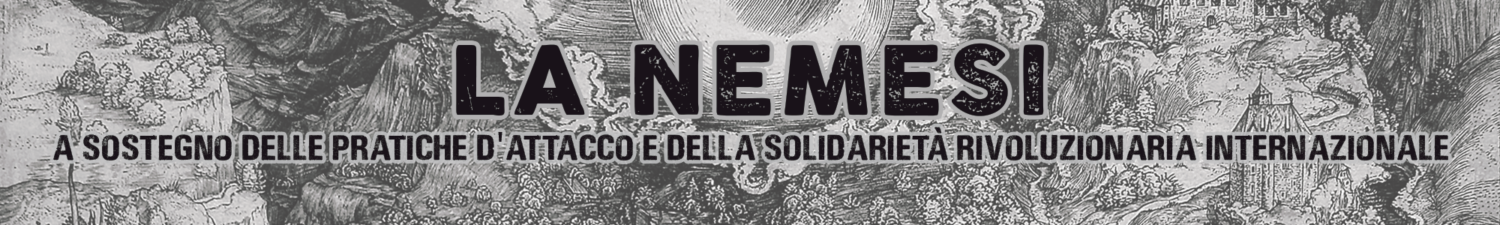DA PARI A PARI
Contro l’autoritarismo identitario
Siamo alcuni compagni e compagne anarchici che hanno preso parte all’assemblea “Sabotiamo la guerra”. Con questo scritto vogliamo prendere parola su una brutta vicenda capitata alla nostra assemblea (non la sola di questo tipo, ma la più grave), ma soprattutto su una forma mentis e un’ideologia che rendono ormai sistematici episodi di questo genere. Se ci presentiamo in maniera tanto circoscritta è perché “Sabotiamo la guerra” è appunto un’assemblea, fatta di volta in volta da chi vi partecipa, e non possiamo parlare a nome di tutti i suoi numerosi partecipanti, passati, presenti e futuri. Fatta questa premessa, cominciamo a spiegarci.
Gli scorsi 11, 12 e 13 ottobre 2024, presso la Villa Occupata di Milano, avrebbe dovuto svolgersi la “tre giorni” di discussione Sfidare la vertigine, organizzata dalla nostra assemblea e dedicata appunto ad alcune delle questioni vertiginose ma ineludibili che ci pone questo presente (a partire da quelle legate alla guerra, che ne costituisce né più né meno che l’orizzonte storico). La “tre giorni” è stata rinviata sine die, e di fatto annullata,per l’opposizione di alcuni (sottolineiamo: alcuni) frequentatori della Villa, i quali accusano di stupro un compagno che partecipa a questo percorso, e l’assemblea stessa di supportarlo. Sarebbe stato più semplice e conveniente, da parte nostra, ignorare questo episodio e tirare avanti, come d’altronde abbiamo fatto in altre occasioni, quando ci sono stati simili tentativi di far saltare nostre iniziative per via della presenza di questo compagno all’interno del nostro percorso. Le nostre coscienze ci hanno invece detto di esprimerci. Essendo a conoscenza delle dinamiche che hanno portato a generare questa grave accusa, e avendo buoni motivi per considerarla infondata, ci sembra una vera e propria ingiustizia che queste voci continuino a circolare senza che nessuno dica niente. Un’ingiustizia verso il nostro compagno e poi verso la nostra assemblea. Ragionandone insieme, ci siamo resi conto che era impossibile affrontare il problema senza entrare nel merito dei presupposti ideologici, etici e di mentalità alla base di questo episodio, mentre farlo è un’esigenza che già sentivamo a prescindere. Se quella contro il compagno è infatti un’accusa molto grave, non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato: è diventato ormai prassi corrente – negli ambienti “antagonisti” come in vasti settori della società – accusare questo o quell’individuo, questo o quel gruppo di colpe infamanti (di volta in volta legate alla sfera sessuale, ai rapporti tra i generi o persino a generiche “dinamiche di potere”) senza farsi carico di fornire motivazioni, né dare a nessuno – si tratti del diretto interessato o di altri – la possibilità di discutere la consistenza delle accuse mosse, o ancora di valutare autonomamente come affrontarle qualora si rivelino fondate. Oltre a questo, ci pare che una certa mentalità e una certa ideologia (che qui chiameremo “identitaria” per motivi che si chiariranno leggendo) stia producendo da anni una serie di dinamiche che vanno ben oltre la sfera della sessualità e dei rapporti interpersonali e che, almeno da parte nostra, abbiamo aspettato fin troppo tempo per tentarne una critica (tuttavia, meglio tardi che mai). Da queste riflessioni è nato questo scritto, che vuole essere un atto di denuncia e un contributo al dibattito che va molto al di là della vicenda da cui è scaturito. Se questo tipo di problemi sta lacerando sempre più mondi, portando nei nostri anche a forme di desolidarizzazione verso intere realtà pesantemente colpite dalla repressione, le ideologie che ne stanno alla base hanno, a nostro parere, anche conseguenze più profonde, e profondamente nefaste. Da qui l’esigenza di guardare tutto questo anche in prospettiva.
Sull’accusa in sé non intendiamo entrare in questa sede. Certi fatti, come si suol dire “delicati” (e anche potenzialmente sensibili da un punto di vista penale) devono essere trattati in spazi e momenti opportuni, quantomeno per non fornire a sbirri e pennivendoli materiale su cui speculare. Ci limitiamo a dire che se considerassimo il nostro compagno uno stupratore non ci organizzeremmo con lui. È inoltre sottinteso – ma è il caso di esplicitarlo – che sia noi come estensori di questo scritto, sia il compagno direttamente accusato, siamo ben disposti a confrontarci faccia a faccia con chiunque ce lo richieda. Abbiamo invece molto da dire sulle modalità con cui simili accuse vengono sempre più spesso mosse, sulla mentalità che le sottende e sulle conseguenze che determinano.
Posto che anche per noi, quando una persona denuncia di aver subito delle violenze, bisogna mettersi in ascolto, questo non può diventare un alibi per non discutere i fatti per quello che sono (o, più modestamente, per come appaiono a noi poveri mortali), né per apporre marchi di infamia su chicchessia senza neanche dargli la possibilità di replicare. Continuiamo testardamente a pensare che chi muove accuse pesanti contro qualcuno – si tratti di aver compiuto una violenza sessuale, di aver rubato soldi da una cassa comune o di essere un delatore – dovrebbe farsi carico di quello che dice, sostenendolo con argomentazioni chiare e circostanziate, e all’interno di spazi e momenti opportuni. Che anche stavolta questo momento di confronto sia mancato ci pare, con tutta evidenza, prodotto di una mentalità che ha sostituito la condizione al fatto, e il vittimismo al pensiero. Siccome il problema non è banale, ci tocca prenderlo un po’ alla larga.
Attraverso la mediazione di quello che possiamo definire femminismo intersezionale, è arrivata da Oltreoceano un’ideologia che recita più o meno così: pensarsi come esseri umani liberi ed eguali, che in quanto tali tentano di sperimentare qui e ora, per quanto è possibile, rapporti di reciprocità (“ciò che puoi fare tu, lo posso fare anch’io, e viceversa”) non è altro che una vecchia fiaba umanistica. Siccome in quella guerra permanente che chiamiamo società noi siamo in realtà diseguali – attraversati, spesso senza rendercene conto, da dinamiche di sopraffazione che ruotano attorno alla linea del genere, del colore, dell’abilità fisica o intellettuale, dell’età ecc. – bisogna essere svegli e vigili (woke, espressione slang americana per “awake”), cogliendo tutte quelle violenze che sono costantemente invisibilizzate e intervenendo nelle relazioni umane per ristabilire l’equilibrio perduto. Da una parte esercitando una moralizzazione permanente dei comportamenti (a partire dalla nota ossessione per il linguaggio), specie se «agìti»da chi ha (o avrebbe) un qualche «privilegio», ovvero una quota di potere sociale in più; dall’altro dando più potere a chi ne avrebbe socialmente di meno. (È con questi “criteri” che ormai diversi anni fa, negli Stati Uniti, alcune femministe proposero di far valere doppio il voto delle donne e degli afroamericani.) Lo sfondo e – insieme – il corollario di questo tipo di visione, è la filosofia postmodernista. Se la verità fattuale non esiste o comunque non è rinvenibile, l’unico “criterio” per orientarsi e decidere in merito ai fatti, che pure non smettono di accadere, diventa l’adesione emo-partigiana al punto di vista di chi è ritenuto più «oppresso». Alla veridicità del fatto si sostituisce l’appartenenza a un determinato soggetto.
Se sarebbe lungo produrre una critica complessiva di questa ideologia, e non possiamo certo farlo in questa sede, una sua prima conseguenza è chiara: la balcanizzazione all’infinito dell’umanità. Se non c’è la possibilità di discutere tra eguali, perché diseguali sono le nostre esperienze e quindi i nostri punti di vista, il risultato non può che essere la guerra di tutti contro tutti, costellata da alleanze più o meno precarie. Con un corollario: siccome nell’universo postmoderno non esistono più valori ma un solo disvalore – affermare qualcosa con una qualche presunzione di certezza – a vincere il confronto non è chi porta l’argomentazione più convincente o fatti incontrovertibili, ma chi sa esibire meglio la propria condizione identitaria di “vittima”, ed ha abbastanza letteratura accademica (i cosiddetti «studies»)alle spalle per essere considerato tale.
Se a taluni questa ideologia sembrerà ultra-libertaria, a noi pare portatrice di un autoritarismo tanto più pericoloso quanto più si nasconde dietro la propria presunta debolezza postmoderna. Se è infatti evidente che queste posizioni troncano ogni possibilità di reciprocità tra gli individui concreti (ciò che puoi fare tu posso farlo anch’io, quindi la mia parola vale quanto la tua), fanno anche rientrare dalla porta di servizio quella ideologia del soggetto che l’anarchismo aveva da tempo cacciato dalla porta principale. Prevedendo che «la religione dell’umanità» avrebbe presto generato i suoi sacerdoti e i suoi burocrati, nel lontano 1844 Stirner scriveva di schierarsi dalla parte dei proletari, ma si rifiutava di «sacralizzarne le mani callose». Fuor di metafora, Stirner afferma che se la condizione di oppressione patita dai proletari va riconosciuta, bisognerebbe evitare come la peste di pensare che il proletariato ha sempre ragione, per il semplice fatto che, come «soggetto», il proletariato… non esiste (esistono solo individui concreti che, tra le altre cose, sono dei proletari), e quindi non può avere né ragione né torto. Al passo con i tempi, bisognerebbe dire la stessa cosa delle donne e dei neri, delle persone omosessuali, degli immigrati e dei transgender. Se riconosciamo la diversa oppressione specifica patita dagli individui appartenenti a queste categorie, la combattiamo solo dove la ravvisiamo concretamente, senza mai rinunciare al nostro giudizio autonomo e senza dare nessuna delega in bianco a chi si iscrive a questa o quella parte di umanità perseguitata. Non solo perché teniamo alla nostra libertà come a quella di chiunque altro, e quindi non daremmo neanche all’individuo più vessato e umiliato del mondo quella che è di fatto una delega di potere; ma perché sappiamo bene che, quando si stabilisce che qualcuno, per una qualsiasi ragione, deve contare più di un altro, ad avvantaggiarsene non sono “gli oppressi”, ma i loro autonominati rappresentanti. Per farci intendere, ci tocca entrare nella parte più scomoda della questione. Quando, nelle nostre piccole collettività, vengono sollevate accuse più o meno fondate di abusi sessuali o di genere, a chi ha qualcosa da ridire viene dogmaticamente ribadito che «bisogna ascoltare le compagne». Ora, già di per sé questa affermazione contiene un’accusa implicita e non per forza giustificata (magari uno ascolta eccome «le compagne», ma non è d’accordo con quanto viene detto); ma soprattutto: ad essere considerate sono davvero tutte le compagne e le donne? Per la nostra esperienza, la risposta è no. Vengono considerate solo quelle compagne e quei compagni (uomini) allineati a posizioni già definite, ovvero ai dogmi della nuova sinistra globale. Tutte le altre donne vengono ignorate, quando non stigmatizzate come complici del loro «patriarcato interiorizzato». A ben vedere, in questa nuova arte d’ottenere ragione, ciò che fa la differenza non è tanto l’appartenenza concreta a una categoria offesa, ma l’adesione all’ideologia che le santifica. A pretendere “ascolto” (ovvero, in realtà, un allineamento rigido e schematico) è la nuova Chiesa sensibilista e politicamente corretta… altro che «le compagne», i «non-bianchi» o i «corpi non normati»!
Ovviamente siamo consapevoli che la violenza sessuale, nelle sue varie forme, non corrisponde sempre e solo all’immaginario comune della mera aggressione fisica; che violenze piccole e grandi esistono anche nei nostri ambienti; che le donne (ma si potrebbe allargare lo spettro a molte altre categorie oppresse) hanno trovato e trovano spesso grandi difficoltà, resistenze e boicottaggi quando le denunciano; mentre siamo favorevoli all’affrontamento collettivo di abusi e violenze e, se necessario, anche ad applicare coralmente delle sanzioni verso chi li ha commessi. Ci sembra legittimo, ad esempio, che una collettività allontani qualcuno da un determinato spazio, o persino da un intero territorio, qualora la sua presenza lo renda infrequentabile da una persona seriamente offesa; oppure che un collettivo rifiuti di organizzarsi (per un determinato periodo, fino a un chiarimento risolutore o anche per sempre) con chi, con i suoi comportamenti, ha incrinato o perso la fiducia dei suoi compagni e delle sue compagne. Ciò che pretendiamo, però, è che tutte e tutti abbiano la stessa facoltà di parola in merito; che le accuse vengano messe alla prova dei fatti, nei limiti in cui una data situazione lo permette (sarebbe atroce, ad esempio, pretendere che chi ha subìto violenza la rievochi per filo e per segno; ma tra questo e una delega di fiducia in bianco si possono trovare praticamente sempre altre possibilità); e che all’accusato sia data la possibilità di difendersi anche negando il fatto, qualora pensi e sostenga di non averlo commesso. Se queste semplici istanze, riconosciute dall’umanità di ogni tempo, e a suo tempo strappate con le lotte allo Stato assoluto, possono avere un po’ l’apparenza del “diritto borghese”, si rifletta sul fatto che i criteri opposti ci riportano né più né meno che al diritto inquisitorio, in cui la sola via al proscioglimento era l’ammissione di colpa (oggi, al passo coi tempi, «di responsabilità»). Si dirà che fatti di questo tipo sono particolarmente difficili da dirimere, perché – oltre a chiamare in causa dinamiche interpersonali sottili – avvengono solitamente in àmbiti privati e intimi, dove nessun altro vede. Questo è verissimo. Ma a pensarci bene la stragrande maggioranza dei fatti umani che danno da discutere avvengono al riparo degli sguardi altrui, o sotto pochi sguardi che facilmente si contraddicono tra loro, avendo magari colto solo indizi riguardo la consumazione di un gesto (pensiamo ad esempio a una situazione in cui sono spariti dei soldi, e nelle vicinanze è stata vista solo una certa persona: qualcuno dice di averla vista a una certa ora o in un certo atteggiamento, un altro in un altro, ma nessuno l’ha vista rubare); i gesti scabrosi che avvengono su una pubblica piazza, o davanti a dieci testimoni che affermano più o meno lo stesso, sono, da che mondo è mondo, una minoranza, e si attirano immediatamente la riprovazione generale. Con che criteri, quindi, in situazioni incerte, si decide se qualcuno ha commesso o non ha commesso qualcosa? In genere, ci si basa sulla verosimiglianza, ovvero sulla comparazione delle dinamiche del fatto con altre analoghe vissute, viste, ascoltate in altri momenti e situazioni (in una parola: sull’esperienza pregressa); il che, in presenza di versioni discordanti, è possibile solo ascoltando e comparando più campane. Si può sbagliare, applicando questo criterio? Certamente, e lo si fa dalla notte dei tempi. Ma ascoltare una campana soltanto, acriticamente e per partito preso, non può che dare ad alcune persone il privilegio (questo sì reale) di mentire, poiché le sgrava dall’onere di fare affermazioni credibili. Qualsiasi cosa, anche molto sensata, si possa obiettare a ciò (per esempio che le differenze di «socializzazione» e vissuto tra uomini e donne non permettono di cogliere appieno certe sfumature), non elimina quella che rimane una conseguenza inaggirabile (a meno che non si sostenga che gli appartenenti a categorie oppresse non possano nutrire secondi fini, e raccontare e finanche raccontarsi frottole – un rischio particolarmente alto in quest’epoca di soggettivismo quasi psichedelico).
Oltre a ciò, sarà mai possibile che, anche nel caso di fatti accertati, venga applicata in maniera pressoché automatica la medesima modalità (l’allontanamento della persona, e la terra bruciata intorno a chi continua a organizzarvisi assieme), senza che si valuti né la gravità specifica del fatto né forme di riparazione possibili, e magari commisurate?
No, questo è reso impossibile. Perché agli attivisti identitari non interessa affatto trovare modi migliori di convivenza tra le persone, ma solo purificare il mondo da tutto ciò che non è loro gradito. Non c’è da stupirsi che, da un po’ di tempo a questa parte, certuni stiano passando dal tentativo di cancellare determinati individui alla cancel culture delle idee e di ciò che più le veicola: i libri. C’è infatti chi ha dato vita a vere e proprie campagne contro case editrici, edizioni e distribuzioni variamente “di movimento” (sia perché curate da persone accusate di abusi, sia perché ree di pubblicare testi considerati «problematici») e a liste di proscrizione contro autori e autrici considerati di volta in volta transfobici, omofobi, sessisti sulla base dell’interpretazione distorta dei loro testi, della partecipazione a iniziative organizzate da altri “incriminati” o persino per la semplice recensione di testi altrui; mentre sappiamo di qualche compagno mai accusato di alcuna violenza, ma che viene diffidato dal presentarsi in determinati contesti per le sue posizioni critiche verso il movimento LGBTQ +, che gli meriterebbero l’accusa di «transfobia». Mentre ci domandiamo con sconcerto da quando in qua gli anarchici si occupano di difendere i riformisti, questa posizione è semplicemente allucinante per disonestà politica e intellettuale. Quello LGBTQ + è per l’appunto un movimento politico che, per quanto giochi a rappresentare tutte le persone omosessuali e transgender, non rappresenta in realtà altro che se stesso. Dire che chi critica l’autoritarismo di alcune frange queer è omofobo o transfobico, è come dire che chi critica Black Lives Matter è per ciò stesso un razzista. Nient’altro, appunto, che politica nel senso peggiore del termine.
Ci dispiace, ma dietro a tanto (e crescente) furore accusatorio e persecutorio, che sta rovinando la vita a sempre più compagni sulla base di accuse sempre più “ardite” e fantasiose, non riusciamo a vedere solo una sincera volontà di opporsi a sessismo e prepotenze, o di accogliere istanze taciute per troppo tempo. Ci vediamo anche un’assunzione di quella cultura della pena che in altri àmbiti si chiama giustizialismo: punire il malcapitato di turno (che sia effettivamente “colpevole” o “innocente”) per dare l’esempio a tutti gli altri. Ci vediamo anche una smania di potere e controllo. Ma soprattutto ci vediamo, più in generale, un veleno autoritario e reazionario che dalle università statunitensi e altri laboratori del potere è penetrato piano piano nell’anarchismo, e che rischia seriamente di estinguerlo dall’interno (mentre la repressione continua a picchiare duro dall’esterno), rovesciandone i princìpi mentre pretende di radicalizzarli. Se c’è un concetto condiviso da tutti gli anarchici, è che l’autorità non limita la tendenza degli umani a sopraffarsi l’un l’altro, ma la aggrava e la rende più strutturale. Ciò detto, l’abolizione dell’autorità e quindi la libertà non è la panacea che libererà l’umanità oppressa da tutti i mali, ma «la via aperta a ogni miglioramento» (Malatesta): un punto di svolta e di inizio, ma proprio per questo necessario. Per quanto si dia arie libertarie e ultra-radicali, la sinistra postmodernista e identitaria ragiona in maniera esattamente contraria. Non si dà alcuna via d’uscita dalla miseria presente, ma solo un’eterna lotta tra soggettività (che si sentono) oppresse all’interno d’una rete di micro-poteri ramificata e onnipresente, che può trovare un po’ di quiete solo in una sorta di reciprocità negativa: anziché un principio che proclama: “faccio ciò che voglio nella misura in cui tu puoi fare ciò che vuoi”, un credo che recita più o meno: “non farò ciò che voglio a patto che tu non faccia ciò che vuoi”. In breve, una serie infinita di divieti. Lo si vede molto bene in certe università occupate dalle giovani generazioni, dove sui muri, al posto dei volantini incendiari, si trovano sempre più spesso intimazioni a non fare questo o quest’altro, insieme alle indicazioni per raggiungere il care team qualora non ci si senta abbastanza safe. Un modello sostanzialmente hobbesiano: se gli individui, divenuti lupi dopo secoli di «etero-patriarcato bianco», sprofondano nella guerra di tutti contro tutti, allora è necessario inventare degli artifici per tenerli a freno: l’eterna giustificazione della polizia. Se poi gli anarchici hanno sempre sostenuto la necessità di distruggere la società presente per permettere l’evoluzione degli individui, ma liberandoli così come sono, la sinistra identitaria pretende di cambiare la società cambiandone i costumi, con la pretesa di procedere dal singolo ai rapporti sociali anziché viceversa. Pura merda reazionaria, degna dei Padri della Chiesa o della Ginevra calvinista del Cinquecento.
Venendo meno il principio di reciprocità, vengono meno le basi stesse dell’autorganizzazione di classe, e la lotta di classe medesima. Da questo punto di vista, è significativo che tra i vari «privilegi» snocciolati dagli identitari non venga mai citata l’istruzione, che pure traccia un solco profondissimo tra le classi, e non solo in termini di accesso al lavoro. Anni fa una compagna, reduce da molti anni di carcere, ci raccontava di quanto in prigione facesse la differenza essere stati o meno “istruiti”, tanto per la conoscenza dei propri “diritti” legali quanto nella capacità di farsi valere davanti alle autorità. Se si considera la loro provenienza universitaria, e l’adozione dei loro precetti da parte di persone che frequentano o hanno frequentato l’università, può davvero apparire casuale questa assenza in mezzo a studies dedicati a ogni tipo di condizione e vessazione? (Con questo, speriamo di non dare involontariamente il suggerimento ad aprire un nuovo filone persecutorio, o spingere qualcuno ad abbandonare francescanamente gli studi: i mezzi culturali servono eccome! e, al pari di altri mezzi, non andrebbero aboliti, ma messi a disposizione delle lotte e della nostra classe). Se infatti certe ideologie, penetrando negli àmbiti “di movimento”, finiscono per raggiungere anche giovani più o meno proletari, esse vengono tipicamente promosse e assunte dalla classe media e in particolare dalla sua variante cognitiva, quella che non vuole cambiare il mondo ma renderlo più civile: da questo l’elusione del problema dell’istruzione, cui spesso si accompagna il disprezzo verso quel proletariato (in specie bianco e quindi grottescamente considerato «privilegiato») che non sa o non vuole assumere il linguaggio e le categorie del “cognitariato” di sinistra, laddove quest’ultimo si percepisce e si presenta come autentico modello del cittadino globale come si deve. Se questa sostanziale indifferenza in materia di classe dovrebbe suggerirci quanto i teorici identitari abbiano davvero a cuore le dannate e i dannati della terra, non fa meraviglia come costoro non si accorgano (ma davvero non se ne accorgono?) di quanto la loro ideologia finisca da un lato per minare le possibilità stesse di organizzarsi tra sfruttati, e dall’altro per rafforzare il securitarismo padronale. Come ci si può organizzare insieme, quando si adotta una visione schizofrenica che considera i propri compagni insieme dei complici e dei nemici (nemmeno tanto) potenziali, segnati dal peccato originale dei propri «privilegi» più o meno di nascita? Quando le qualità personali – l’impegno, la schiettezza, l’affidabilità, il coraggio nelle sue varie forme, la capacità di ragionare e argomentare, la coerenza con quanto si proclama – vengono squalificate a meri mezzi di sopraffazione? Quando non si può prendere alcuna decisione comune senza che venga evocato il fantasma della «sovradeterminazione»? Se si smette di considerare l’uguaglianza un concetto-limite (lo spazio che permette l’espressione delle differenze, e in cui emergono per forza anche alcune disuguaglianze), il risultato non può che essere la paralisi, e una miseria generalizzata in cui le differenze, ovvero ciò che fa la ricchezza di qualsivoglia collettività, vengono annientate in nome di un egualitarismo astratto e disciplinante (mentre a spadroneggiare sono, orwellianamente, quanti pretendono di essere «più uguali degli altri»).
Certamente anche il “classismo”, a suo modo, è identitario; ma si tratta di un modo profondamente diverso dai vari identitarismi di genere, “razza” e quant’altro, e che apre tutt’altre possibilità. Senza disconoscere che anche la linea del genere e quella del colore hanno un peso nell’articolazione dei rapporti di potere, oppressione e sfruttamento (e nell’economia complessiva dell’attuale dominio capitalistico), solo la linea della classe apre a una liberazione universale, creando quella rottura verticale in cui le liberazioni delle donne, degli omosessuali e transessuali, delle minoranze (post)coloniali “interne” ed “esterne” ecc. si possano realizzare senza snaturarsi in nuove configurazioni di potere e del dominio. Essere sfruttati e sfruttate, infatti, ha almeno due aspetti differenti dall’essere donne, neri ecc. Il primo è che si tratta di una condizione meramente sociale, non legata a tratti fisiologici: si è sfruttati finché esiste una società basata sullo sfruttamento; con la fine del razzismo e del sessismo si smetterebbe di essere «socializzati» come uomini e donne, «razzializzati» come neri ecc., ma non si smetterebbe di essere uomini, donne, neri. Il secondo aspetto è che il sesso, il colore della pelle, l’orientamento sessuale ecc. sono caratteristiche che – salvo eccezioni, ovviamente – la gran parte degli individui non vorrebbe perdere in un processo di liberazione, ma semplicemente poter incarnare senza tutte le discriminazioni, umiliazioni e stereotipi che vi sono associati – ovvero sono caratteristiche non indesiderabili di per sé; mentre nessuno (psicosi lavoriste-stakanoviste a parte) vorrebbe restare uno sfruttato. Nella sua mera negatività, il cui sbocco ultimo è l’autosoppressione della classe sfruttata nel momento in cui questa sopprime la classe sfruttatrice, solo la linea della classe realizza un umanesimo non-astratto (nessuna equiparazione tra sfruttati e sfruttatori in nome della comune ”umanità”, ma un processo che potrà dare forma a un’umanità diversa), aprendo lo spazio alla liberazione di tutti e di ciascuna, mentre colpisce laddove il sistema può al massimo arretrare, ma non ricrearsi come sistema di sfruttamento: un capitalismo senza razzismo, sessismo e persino senza generi e differenze “razziali”, potrebbe, almeno in astratto, esistere; una società di classe senza classi, no. Transfemminismo, “teoria critica della razza” ecc. tendono ad applicare l’antagonismo pressoché assoluto del classismo, possibile perché basato su alterità meramente sociali, ad alterità incarnate negli esseri (in linguaggio filosofico: ontologiche) e/o di cui gli individui concreti non vogliono (e non dovrebbero) per forza disfarsi. Il risultato è quasi sempre un pasticcio in cui affiora un certo razzismo di ritorno, laddove certi individui (maschi, e poi a cascata etero, bianchi, “abili” ecc.) patiscono una squalifica di fondo per ciò che sono e non per ciò che fanno, e in cui le stesse persone vengono da una parte riconosciute come oppresse e potenzialmente complici, e dall’altra, non appena subentra un contrasto, trattate come “nemici di categoria” contro cui serrare le file dei “propri”. Questo non significa che conflitti di natura diversa da quello di classe non esistano o non abbiano mai ragione di essere aperti, se necessario anche con durezza (lo ribadiamo: non sacralizziamo le mani callose): ciò su cui ammoniamo è il modo di considerarli e trattarli, che dovrebbe avere le sue caratteristiche specifiche. Se non si è capaci di operare queste distinzioni, le conseguenze sono catastrofiche. Di fronte a una vertenza in una fabbrica o in un magazzino, noi stiamo sempre dalla parte degli operai, e poco ci importa di chi dice il “vero” (possiamo pure dirci tra noi che gli operai stanno dicendo cazzate, ma questa rimane una questione inter nos, che semmai discuteremo da questa parte del cancello). Possiamo dire la stessa cosa quando il conflitto si apre tra un compagno (uno sfruttato, un amico) e una compagna (una sfruttata, un’amica)? O, a cascata, tra un compagno gay (o trans, o nero) e uno etero (o cis, o bianco)? Quando un padrone o un governo fa un passo falso – che gli attira in un modo o in un altro la riprovazione pubblica – è assolutamente sensato attaccarlo, ricavandone ciò che se ne può ricavare per l’avanzamento della lotta, senza stare troppo a discettare di quanto sia effettivamente “grave” ciò che ha commesso. Si può dire la stessa cosa… ecc.?
L’applicazione meccanica di logiche tipiche della lotta di classe a conflitti d’altro genere finisce per uccidere la lotta per la liberazione. Venendo frammentato in una serie di micro-conflitti, peraltro facilmente esposti a cortocircuiti logici (chi è più oppresso tra un «non-bianco cis-etero» e una «bianca transgender»? con chi ci si schiererebbe in caso di dissidio?), il conflitto verticale (sfruttati contro sfruttatori, rivoluzionari contro Stato) viene fagocitato da un perenne conflitto orizzontale. Un paradigma che peraltro somiglia (siamo i soli a notarlo?) a una sorta di contraltare di sinistra alla guerra tra poveri fomentata negli anni dalle destre; e che, brandendo la safety al posto della security, contribuisce ai medesimi obiettivi di pacificazione sociale (diritti per tutt* e ovunque, libertà per nessuno e da nessuna parte). Il desiderio di essere protetti e garantiti nel proprio isolamento contro i propri simili, sempre più percepiti come dissimili, si sostituisce all’urgenza di liberarsi insieme a tutti gli altri.
Prima di concludere questa serie di considerazioni, ci preme chiarire un punto, onde evitare possibili (e magari furbeschi) fraintendimenti. Le critiche di cui sopra non possono essere applicate meccanicamente e in toto a tutti i gruppi di ispirazione identitaria: quelle che ci interessa è fotografare delle tendenze, ed è in questo senso che queste considerazioni vanno lette. Allo stesso modo, a differenza di altri, noi non vogliamo attribuire a tutti coloro che variamente aderiscono a ideologie e approcci identitario-postmodernisti la colpa di tutte le derive che hanno attraversato i movimenti antagonisti negli ultimi anni (dall’adesione al securitarismo sanitario-Covid all’appoggio a una inesistente “resistenza” nella guerra in Ucraina). Se il vittimismo tipico di queste ideologie ha fornito, soprattutto all’estero, un contributo più che “generoso” a queste derive (si veda il raduno internazionale di Saint-Imier nel 20231), simili sbandate sono state spesso trasversali a ideologie e aree (si sono avute, per esempio, da parte di raggruppamenti di varia tendenza marxista o libertaria che poco o nulla hanno a che fare con l’identitarismo postmoderno), mentre in Italia, soprattutto in àmbito anarchico e libertario, c’è stato un salutare smarcamento di segno opposto che ha attraversato mondi diversi, compresi alcuni ambienti queer e transfemministi. Ci fa inoltre piacere constatare, a livello internazionale – pensiamo soprattutto agli Stati Uniti – che i tentativi del potere di creare distanze dalla resistenza palestinese agitando gli spettri dell’”oscurantismo religioso” e dei presunti “stupri di Hamas” (una fake news cui pure, inizialmente, qualcuno ha abboccato e qualcun altro continua ad abboccare) sono andati in gran parte a vuoto, e che molti compagni e compagne di lotta di tendenza transfemminista, intersezionale ecc. si sono schierati anima e corpo con gli oppressi palestinesi (con tanto di benedizione da parte della papessa Judith Butler). Di fronte a queste semplici constatazioni, certe analisi troppo manichee ci sembrano inadeguate alla realtà confusa, complessa, mutevole del nostro tempo, e non le facciamo nostre. Ciò che vogliamo suggerire è qualcosa di più sottile, che ha a che fare col modo in cui agiscono le idee a livello sociale e individuale, portando gli individui anche dove non vorrebbero arrivare. Quando cominci a ragionare in un certo modo, diceva ancora Malatesta, non vai dove vuoi tu, ma dove ti porta il ragionamento. Un esempio potrà chiarire cosa intendiamo.
Non ci sembra esattamente un caso che non solo il mercato e lo spettacolo, ma persino le istituzioni e le forze dell’ordine abbiano ormai fatto proprie retoriche ispirate all’identitarismo woke, con preziosi ritorni in termini di controllo sociale (militarizzazione giustificata dalla «difesa delle donne», ergastolo automatico per i «femminicidi», ma anche interventi sempre più frequenti degli sbirri nelle scuole, contro violenze di genere, «bullismo», «abilismo» e quant’altro, cui si affiancano frotte di psicologi a caccia di insicurezze, disagi… e clienti). Che tante (trans)femministe replichino che la maggior parte degli stupri avvengono in realtà in casa e da parte di persone conosciute, o che oppongano a simili strumentalizzazioni la presenza e l’autodifesa diretta delle donne nelle strade, o la denuncia del carattere comunque «patriarcale» della polizia e finanche del «sistema» nel suo insieme, ci sembra senz’altro apprezzabile, ma anche insufficiente di fronte a una propaganda onnipervasiva che raggiunge sempre più persone (e in specie i giovanissimi) direttamente sui loro smartphone, e che spinge sempre più categorie (donne, persone omosessuali, transessuali, “colorate”, con disabilità, “neurodivergenti” ecc.) a sentirsi perennemente sotto attacco da parte di chi avrebbe qualche «privilegio» in più (o qualche problema in meno). Non molti anni fa, in Francia, degli spazi anarchici colpevoli di proclamare e praticare la loro intolleranza contro tutte le religioni sono stati attaccati con la taccia di «islamofobia»2, mentre in diversi territori degli Stati Uniti, a furia di voler fare gli interessi delle “minoranze” mettendole al riparo dalle insidie dei “privilegiati”, si sta tornando di fatto alla segregazione razziale, con scuole e classi separate per i soli neri3. Non sarebbe il caso di tentare una riflessione più profonda, prima che sia troppo tardi? Purtroppo – e qui, viceversa, ci tocca tirare in ballo la gran parte delle realtà infette dal morbo identitario – quello che viene fatto è sistematicamente il contrario: non appena qualcuno solleva questioni scomode per le loro ideologie o per qualche loro alleato, gli attivisti identitari – col silenzio-assenso dei loro amici più “moderati” – gli si gettano alla gola puntando il dito su questa o quella uscita infelice, questa o quella parola, questa o quella virgola fuori posto (spesso mescolando, alla bisogna e senza vergogna, ciò che uno scrive con calma alla propria scrivania con quel che gli esce di bocca nella foga di una discussione, o davanti a un bicchiere di vino); e così evitano di dover affrontare le questioni stesse. Quello che viene messo in campo, di fatto, è una serie di dispositivi che impediscono tanto di discutere quanto di pensare (senza possibilità di confronti, alla lunga il pensiero muore).
Ecco l’aria da Chiesa che da troppo tempo ci tocca respirare, e di cui ne abbiamo fin sopra i capelli. Ecco ciò che denunciamo, al di là dell’occasione che ha generato questa denuncia. Il problema, per noi, non è tanto che questa serie di dispositivi fattasi ideologia abbia generato, nei nostri ambienti, una grande quantità di scazzi (se non sempre inutili o infondati, quasi sempre malgestiti); ma soprattutto che, assestando colpi micidiali al pensiero critico, vi ha innescato un vero e proprio processo di degrado etico, cognitivo, spirituale. Che tipo di ambiente morale e intellettuale può prodursi, quando si smette di ragionare sui fatti lasciando campo libero a un soggettivismo sfrenato e allo stesso tempo imprigionato in categorie stagne, che arriva a propinare dogmi demenziali (demenziali come tutti i dogmi, la cui essenza è di dover essere creduti pur restando incomprensibili) come «violenza è ciò che una persona percepisce come tale» (e a «violenza» si può sostituire a piacimento «sovradeterminazione», «potere» ecc.)? L’interiorità senza esteriorità, diceva Hegel, è vuota. Senza passare dall’incontro-scontro con la realtà come suo momento di verifica, e quindi senza presupporne l’esistenza e la possibilità di indagarla, la soggettività non diventa altro che una girandola perpetua di sensazioni, emozioni, percezioni (e paranoie). Se in questa fase storica sono gli individui in generale a essere sempre più prodotti come individui senza mondo dall’ultra-soggettivismo dilagante (e dalla smaterializzazione informatica del reale); e se qualsiasi impostazione ideologica agisce come un filtro, determinando quali tipi umani tenderanno ad avvicinarsi o allontanarsi da determinati ambienti,è fatale che, laddove domina la paranoia woke, si avvicinano e si avvicineranno sempre di più ai “movimenti” proprio i tipi più inconsistenti, sconclusionati e tendenzialmente rancorosi: quelli poco propensi al ragionamento e molto propensi al lamento; quelli che non amano fare seri sforzi per identificare e combattere il Potere (quello vero), e molto amanti della lotta a buon mercato contro il “potere” diffuso ovunque… ma soprattutto vicino a loro; quelli che cercano un gruppo che si prenda cura delle loro paturnie, anziché sfidare ogni collettività e quindi arricchire quelle che si scelgono liberamente con l’originalità delle proprie tensioni e idee; quelli che non vogliono essere individui irripetibili, e quindi irriducibili a qualsiasi categoria ma, appunto, soggetti.
In questa corsa all’annichilimento della realtà e, insieme, dell’individualità pensante, in cui l’autoritarismo trova una dimora accogliente e in cui risorgono in forma nuova i ferrivecchi della reazione, un episodio come quello di Milano, e come altri occorsi alla nostra assemblea nel suo anno e mezzo di vita (ma risòltisi più felicemente), ci rattristano ma non ci stupiscono. L’autorità e l’autoritarismo rimpiccioliscono sempre gli esseri umani e imbruttiscono sempre i rapporti. Non è quindi strano che, in questa mezzanotte del secolo, tutte le porte siano spalancate ai piccoli Torquemada e agli opportunisti senza princìpi, e chiuse in faccia a chi si ostina a dire parole chiaresu un presente molto più tragico che serio.
In mezzo a tanta merda reazionaria di ritorno noi andiamo avanti, con i nostri princìpi ben stretti in pugno.
Penisola italiana, primavera 2025
Cinque piccoli indiani fuori dalla riserva
1Per uno sguardo su quanto accaduto in quell’occasione si veda il testo Grosso guaio a St Imier sul blog della trasmissione radiofonica “la nave dei folli”, a questa pagina: https://lanavedeifolli.noblogs.org/files/2023/09/Grosso-a-guaio-a-St-Imier.pdf
2Si veda ad esempio https://danslabrume.noblogs.org/post/2023/07/24/anti-anti-racialisme/
3Cfr. Yascha Mounk, La trappola identitaria, Feltrinelli, Milano 2024
* * *
PDF: Da pari a pari. Contro l’autoritarismo identitario
[Ricevuto via e-mail e pubblicato in https://lanemesi.noblogs.org/post/2025/07/02/da-pari-a-pari-contro-lautoritarismo-identitario/]