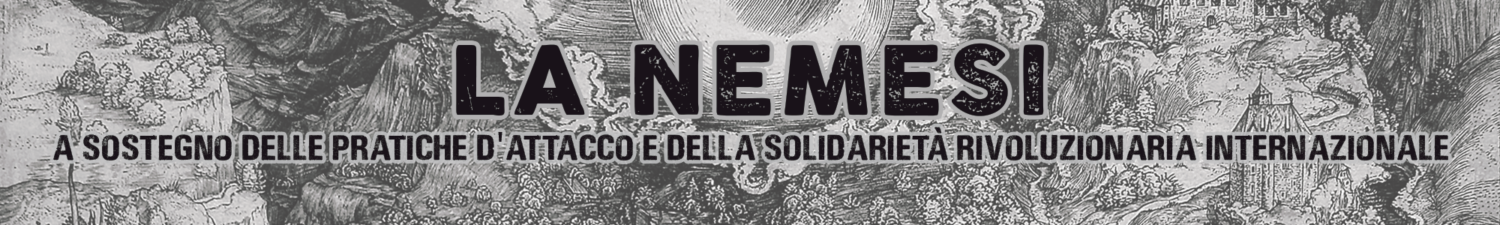La disputa del sacramento
Tutti o quasi tutti conoscono la pittura di Raffaello denominata la Scuola di Atene. I grandi filosofi dell’antichità che discutono liberamente, disordinatamente, lasciatecelo dire anarchicamente, a gruppi, a coppie, chi buttato per terra.
A nessuno, o quasi nessuno, dice niente invece il sintagma “la disputa del sacramento”. Eppure la Disputa del Sacramento è anch’essa una pittura di Raffaello, per la precisione un affresco, e si trova nelle stesso luogo della Scuola di Atene, all’interno dei Musei Vaticani, nell’area denominata “le stanze di Raffaello”: precisamente nella stessa stanza, i due affreschi sono l’uno dirimpettaio dell’altro. Si tratta della cosiddetta Stanza della Segnatura, dove le quattro pareti vengono rispettivamente affrescate con motivi dedicati alla teologia, alla poesia, alla filosofia e alla giustizia. E in effetti la Scuola è per molti aspetti opposta alla Disputa. In quest’ultima si evince innanzitutto il dualismo tra cielo e terra, dunque il rapporto gerarchico, verticale, anti-anarchico tra i due mondi. In cielo i santi e i profeti se ne stanno in emiciclo, con Gesù al centro che fa il presidente della camera e discutono dei dogmi della fede; in terra vescovi e dottori se ne stanno anche loro in emiciclo e in base alla sacra interpretazione del dogma, dettano, scomunicano e costituiscono la moderna Chiesa. In cielo la Chiesa trionfante, in terra la Chiesa militante.
Che quasi nessuno fra il grande pubblico colleghi tra loro le due opere, ha a che fare con quella che con Walter Benjamin potremmo chiamare la condizione dell’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. La Scuola di Atene, che è ovviamente molto più bella, a partire proprio dall’immaginario di chi non è esperto in materia – giacché la discussione libera e anarchica è infinitamente più bella della dettatura dei dogmi della fede – la Scuola di Atene è stata dunque isolata, riprodotta nei volumi d’arte patinati, nelle cartoline, nei poster, persino nei manifesti dei compagni, infine isolata digitalmente, condivisa nei social, nelle pubblicità, ecc.
Non bisognerebbe invece dimenticare il legame e la contrapposizione che intercorre tra le due opere: il dogma nella parete occidentale, il dibattito in quella orientale.
* * *
Torniamo a far lavorare i nostri trenta polpastrelli non per disquisire di storia dell’arte, ma perché siamo stati indirettamente coinvolti in un’iniziativa stupida e provocatoria. Il nostro primo scritto collettivo, Cum grano Salis, non sappiamo in effetti se per stupidità o proprio per la natura provocatoria degli organizzatori, è stato citato nelle reading suggestions (il solito anglismo per dire “i consigli di lettura”) all’interno della cosiddetta Fiera dell’editoria e della propaganda anarchica (dove però i progetti editoriali e di propaganda anarchici non sono benvenuti).
Chi vuole può rileggere il nostro scritto qua:
https://ilrovescio.info/2024/07/20/cum-grano-salis-a-proposito-di-elezioni-antifascismo-e-guerra/
Siamo già stati abbastanza noiosi la prima volta, che non ci abbandoneremo a una esegesi esplicativa del contenuto di Cum grano Salis. Quello che però dovrebbe essere chiaro a chiunque un possegga ancora, in effetti, qualche grano di sale in zucca, è che il nostro scritto si schiera esattamente contro quelli come voi.
Basta leggere il programma – quello che c’è e quello che manca, per esempio la guerra… ops che sbadataggine – per rendersi conto che l’evento in questione si inserisce a pieno nel contesto di quella sinistra postmoderna e liberale di cui parliamo nel nostro articolo: rispetto a chi si candida alle elezioni, ci sono differenze di grado, di tattica e di etica, ma non qualitative.
Se poi la discriminante fondamentale per la costituzione del Fronte viene individuata nelle questioni di genere, nemmeno nell’intera società, ma dentro il ghetto al quale si appartiene, siamo semplicemente all’onanismo intellettuale. Anche su queste questioni, come su tutto nella vita, noi siamo per il metodo della Scuola di Atene: l’uso critico e libero della ragione, la quale distingue i casi e concede a chiunque la possibilità di esporne le proprie, di ragioni. Non certo per il metodo della Disputa del Sacramento: deduzione dogmatica delle verità rivelate nelle Scritture (pardon… nei comunicati) e la scomunica.
Naturalmente non abbiamo copyright e se vi va di leggere il nostro articolo buon pro vi faccia. A nostra volta di scomuniche non ne emettiamo; convinti che anche tanti compagni validi frequenteranno questa iniziativa, come nella pittura che preferiamo di Raffaello continueremo a discuterci insieme, a coppie o a gruppi, distinguendo i casi e le responsabilità eventualmente da recriminare.
In ambito anarchico ognuno dovrebbe essere libero di proporre i contenuti che preferisce e gli altri eventualmente saranno liberi di non condividerli e criticarli. Ulteriori questioni riguardano il metodo ed il linguaggio. La forma è sostanza e nell’etica anarchica il fine non giustifica il mezzo, cioè se il metodo è autoritario il fine non può essere anarchico.
Quindi ci domandiamo quali siano mezzi e fini di una fiera della propaganda e dell’editoria anarchica che ha tra i pochi non confusi presupposti della propria indizione la censura di realtà editoriali anarchiche e l’esclusione di compagni e compagne anarchiche?
Perché gli organizzatori, che si premurano con tanto zelo di escludere gli editori di movimento da
un’iniziativa che dovrebbe riguardare il mondo delle produzioni indipendenti, non si fanno
problemi a presentare testi di case editrici commerciali e accademiche?
Perché quelli che pongono tra i punti del proprio agire politico l’importanza del linguaggio scrivono un testo di posizionamento con lo stile dei più vili politicanti, cioè partendo da un presupposto condivisibile – “la stampa anarchica è sotto attacco” – finiscono con il sostenere l’esatto contrario, cioè la desolidarizzazzione contro chi è colpito dalla repressione?
Ogni compagno e compagna dovrebbe avere la capacità di ragionare da sé su queste domande. Vorremmo concludere con la poesia inaspettata che ci regala talvolta la geometria, incantati di fronte alla contraddizione del rapporto che intercorre tra il concavo e il convesso. Roma è piena di cupole meravigliose, magistralmente scolpite e divinamente affrescate. Ma tutto questo è solo la parte convessa della cupola. Fuori da quella chiesa, c’è il resto del mondo. L’enormità anti-intuitiva del concavo. E noi restiamo convinti che la chiesa più bella è sempre quella che brucia.
I Tre Moschettieri
[Ricevuto via e-mail e pubblicato in https://lanemesi.noblogs.org/post/2025/04/07/la-disputa-del-sacramento/]