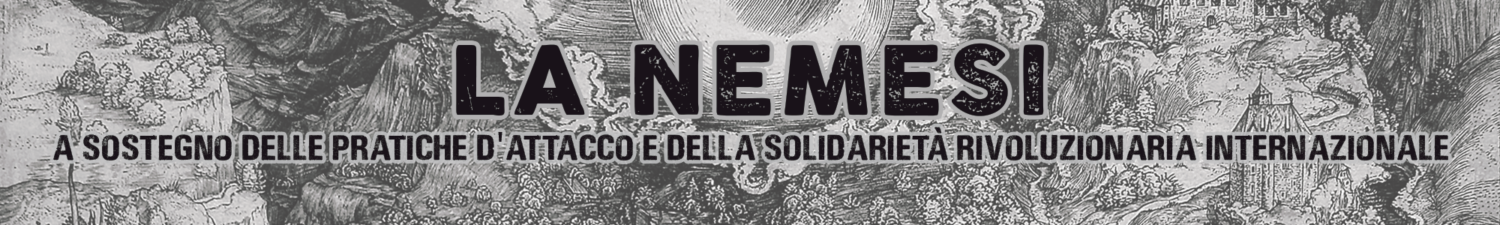Ripubblicazione dell’articolo presente nel numero 7 del giornale anarchico Vetriolo: “La fase nichilista”
Non molti giorni fa abbiamo pubblicato un contributo dal titolo “Alcune considerazioni critiche su La fase nichilista“, pervenutoci via e-mail.
Non entrando qui nel merito dell’argomento, ma ritenendo il confronto una parte necessaria dell’elaborazione e dello sviluppo di auspicabili ampliamenti di teorie e pratiche rivoluzionarie, ed essendoci inoltre resi conto della impossibilità di reperire su internet lo scritto fatto oggetto di critiche, abbiamo deciso di riproporre l’articolo “La fase nichilista”, contenuto nel numero 7 del giornale anarchico Vetriolo, ripubblicandolo online.
Di seguto la versione integrale del testo e il relativo file in formato PDF.
* * *
LA FASE NICHILISTA
L’ipotesi espressa sulle colonne di questo giornale secondo la quale, sul terreno del conflitto sociale, si starebbe entrando in una cosiddetta «fase nichilista», ha suscitato interesse, curiosità e critiche. Alcuni compagni, soprattutto fuori dall’anarchismo, ci hanno rimproverato le nostre pulsioni nichiliste. Altri, al contrario, essi stessi fieri nichilisti, ci hanno rimproverato di aver relegato il nichilismo a una semplice «fase», in qualche modo relativizzandolo e quindi non sposandolo a pieno. Dietro a queste critiche c’è un fraintendimento e un equivoco circa le nostre tesi. Fraintendimento ed equivoco di cui ci prendiamo volentieri la responsabilità – probabilmente non ci siamo spiegati bene.
Lo scopo di questo articolo, quindi, è di esplorare a pieno questo concetto, che fino a questo momento, per quanto importante, è stato da parte nostra sviluppato sempre all’interno di altri discorsi: per esempio, ne abbiamo parlato nei nostri articoli sulla scienza e la tecnica, oppure gli abbiamo dedicato una delle cosiddette «dodici ipotesi». Questa volta vogliamo invece prendere di petto la categoria, esplorandone i nodi essenziali e derivandone delle considerazioni collaterali.
La fase nichilista come passione degli sfruttati.
Quando parliamo di «fase nichilista» noi intendiamo descrivere una certa condizione patita dall’essere sociale. Quello che cerchiamo di descrivere è un sentimento nel quale sono gettati gli sfruttati nella presente fase storica. Quando ne abbiamo trattato per la prima volta, per noi l’emergenza di una fase nichilista era ancora solamente una previsione. Immaginavamo che, a causa dell’alienazione tecnologica, del suo sottrarre ai proletari ogni possibile orizzonte, fosse pure immaginifico, di rovesciamento rivoluzionario, questi si sarebbero presto trovati in tale condizione. Col tempo questa previsione è diventata una realtà. Una realtà non del tutto precipitata: la fase nichilista è iniziata, ma non ne abbiamo ancora raggiunto il parossismo (siamo solo alle prime scosse telluriche). Per tale ragione nel presente articolo la fase nichilista da noi descritta avrà ancora un residuo di ambiguità: in parte descrizione, in parte previsione del divenire dell’essere sociale.
Un completo fraintendimento della fase nichilista è stato operato anche da sbirri e magistrati. Nell’operazione repressiva di cui siamo stati oggetto, culminata con gli arresti e le perquisizioni dell’11 novembre 2021, in diversi passaggi veniamo accusati di «istigazione» anche per aver teorizzato la «fase nichilista». Premesso che non intendiamo difenderci da queste accuse, di cui andiamo per altro piuttosto fieri (per quanto nel concetto di istigazione rimanga una sfumatura fastidiosa, come se noi spingessimo altri a fare delle cose che non abbiamo il coraggio di fare in prima persona… ma non è questo il luogo per parlarne), va detto che, obbiettivamente, considerare la fase nichilista di “Vetriolo” come una condizione che noi peroriamo e alla quale istighiamo significa non aver capito un tubo di questo concetto.
La fase nichilista di cui noi vagheggiamo è una passione degli sfruttati. Questi godono e godranno della fase nichilista, e allo stesso tempo ne patiranno gli effetti. In quanto passione e patimento reale, oggettivo e soggettivo di massa, la fase nichilista non è qualcosa che gli anarchici possono provocare o meno con la loro volontà singolare. Gli anarchici fanno le azioni, non le rivoluzioni. Le rivoluzioni le fanno le classi sociali (questo è l’ABC di ogni discorso sociologico, se non ci intendiamo su questo è inutile continuare a discutere). La fase nichilista di cui noi parliamo non è la stessa cosa delle azioni nichiliste, che ovviamente salutiamo sempre con gioia. Noi qui intendiamo, con il sintagma «fase nichilista», una transumanza di massa sul terreno del nichilismo. Queste cose non è che si istigano, queste cose accadono e basta.
Chiarito questo punto – la fase nichilista è una passione degli sfruttati nel momento in cui viene rapinato loro il sogno di una svolta rivoluzionaria, a causa dello sviluppo scientifico – abbiamo dunque due sotto-concetti da esplorare: 1) la fase nichilista come evento che si verifica nel momento della rimozione di ogni residuo di coscienza di classe; 2) la fase nichilista come reazione di massa alla svolta tecno-autoritaria. Vediamoli separatamente.
Il ritorno del rimosso. Lotta di classe e furia del dileguare.
Questi sono gli anni della grande rimozione della lotta di classe. Essa è scomparsa dall’orizzonte narrativo dell’epoca storica in cui viviamo. Sono gli anni della fine della storia. Quando Francis Fukuyama elaborò la sua teoria su La fine della storia (1992) lo fece paradossalmente (ma è in fondo davvero così paradossale?) dalla prospettiva di un hegelo-marxismo da connotati tanto rigidi da apparire quasi dottrinari. Se la storia nasce con la dialettica servo-signore (Hegel, Fenomenologia), ovvero se la storia dell’uomo è storia di lotta di classe (Marx-Engels, Manifesto), allora, dice Fukuyama, ecco che con la sconfitta dell’Unione Sovietica lo storia è finita. Andate in pace.
Non solo il Nostro identifica in maniera addirittura stalinista gli interessi imperialistici dell’URSS con gli interessi tout court del proletariato, quando noi anarchici da 150 anni diciamo che «ogni governo sedicente rivoluzionario non è che un inganno in più» e che «il compito storico del proletariato è la distruzione di ogni potere politico» (Saint-Imier, 1872), ma arriva persino a rovesciare la premessa maggiore con la minore, deducendo, dal tramonto dell’effetto, la scomparsa della causa.
La rimozione della lotta di classe ha permesso al potere politico anche di rimuovere le rappresentazioni mistificate che di questa venivano fatte nel teatrino parlamentare. A cascata, quindi, la scomparsa di sedicenti forze politiche che millantavano di fare gli interessi degli sfruttati è andata di pari passo con una svolta autoritaria delle democrazie occidentali. Non dovendo più porsi come mediazione istituzionale dei conflitti sociali, la democrazia parlamentare si è evoluta sempre più come una copia ridondante delle gilde economiche. Questo si ricollega con un’altra ipotesi di “Vetriolo”: l’avvento di una svolta autoritaria di nuova forma.
Il movimento anarchico non è stato esente dalle suggestioni di questa ondata. Alcuni, sempre pronti a recepire le idee peggiori del nemico, hanno pensato che si sarebbero dimostrati tanto più radicali, tanto più adeguati alla moda dei tempi, se si fossero messi anche loro a belare insieme al gregge politico il rinnegamento delle nostre origini nel movimento operaio.
Il punto sta proprio nell’impossibilità di questa rimozione. Le ingiustizie sociali, le diseguaglianze, al contrario, non hanno fatto altro che accentuarsi nell’ultimo trentennio. In questo contesto, il sentimento naturale dell’odio di classe da parte della massa crescente degli esclusi si è trovato represso in una condizione innaturale, dove questo stesso odio non poteva e non sapeva esprimersi. La fase nichilista non è altro che questo: il ritorno, sotto forma sintomatica, come un fiume carsico, dell’odio di classe rimosso. Contro il mito dell’autocoscienza, chimera sempiterna dei riformisti di tutte le epoche, l’odio di classe è diventato un odio cieco e nichilista, un odio incosciente. Prime scosse: le sommosse di Los Angeles e Parigi.
I primi a sperimentare davvero la fase nichilista sono stati però i popoli di religione mussulmana. Dietro all’incapacità di comprendere la furia del dileguare del cosiddetto terrorismo islamico ben pochi sono riusciti a intravedere che quella era la risposta, nonché la mistificazione, di un sentimento di odio autentico verso il capitalismo occidentale. Ora la fase nichilista comincia ad attraversare l’Occidente, ma ancora i suoi connotati vengono disconosciuti e la sua portata non del tutto compresa. La sinistra in particolare si sta dimostrando completamente cieca in materia. Si rimprovera alla fase nichilista la sua irrazionalità. È come rimproverare all’acqua la sua umidità! I residuati bellici del socialismo scientifico non riescono ad accettare che tra gli oppressi ci sia un’ondata di odio anti-scientifico, alla new left all’americana non va proprio giù che gli incazzati siano spesso operai bianchi, maschi, un po’ pure razzisti e sessisti. Dietro a questo sentimento aristocratico nei confronti della fase nichilista sta il successo, per esempio, del modello Trump.
Dovremmo al contrario comprendere che dietro all’odio nichilista c’è, per quanto ben nascosto, un autentico sentimento di odio di classe. Sposare insomma la fase nichilista e scavare a fondo. Se questa si presenta come ritorno dell’irrazionale, come ritorno del mito, dovremmo allora essere noi i primi a rilanciare il mito dell’anarchia vendicatrice. Cioè pensare, dentro la fase nichilista, alla diffusione di pratiche di verticalizzazione dell’odio. Propaganda col fatto, è sempre stato questo: con le pratiche si mostra un orizzonte e si dimostra che le cose possono cambiare, che la nostra rabbia può e deve essere indirizzata.
La Chiesa tecno-scientifica e i suoi nemici.
La seconda epifania della fase nichilista si mostra sul terreno del sentimento anti-scientifico sempre più diffuso. Di nuovo, si tratta, per definizione, di un sentimento irrazionale. Dentro a questa irrazionalità ci sono molto spesso delle vere e proprie follie, complottismi, paranoie. Se però rinunciamo a un atteggiamento elitario, ci rendiamo conto che tali sono i sentimenti di chi è stato gettato in una condizione dove ogni rovesciamento possibile è stato rimosso. D’altronde, se pure un filosofo (nazista) tanto amato a sinistra come Martin Heidegger arrivò a dire che, di fronte alla degenerazione scientifica e ai pericoli del nucleare, ormai «solo un dio ci può salvare», cosa pretendete che possa pensare l’uomo della strada?
Noi anarchici però abbiamo gli strumenti per affrontare questa condizione. Scriveva Michail Bakunin:
«Nell’attuale organizzazione, in quanto monopolisti della scienza che restano come tali al di fuori della vita sociale, gli scienziati formano certamente una casta a parte che offre molte analogie con la casta dei preti. L’astrazione scientifica è il loro Dio, le individualità viventi e reali sono le vittime ed essi ne sono gli immolatori consacrati e patentati».
Bakunin aveva individuato, già 150 anni fa, i punti cardine della condizione nella quale ci troviamo.
1) La conoscenza scientifica è essa stessa una potenza economica, privata ed esclusiva. Gli scienziati sono i monopolisti di questo trust.
2) Essendo dei monopolisti del concetto, essi rappresentano a tutti gli effetti una casta a parte, come i preti nel medioevo o gli scriba egizi.
3) La scienza è il loro Dio e gli individui le vittime da sacrificare in olocausto.
Queste tre condizioni, già previste da Bakunin, oggi sono presenti in maniera impressionante nelle nostre società. Il monopolio dei mezzi di conoscenza è stato derivato da una sempre maggiore complicazione e specializzazione del sapere tecnico. Miliardi di persone usano Google ogni giorno, poche decine conoscono gli algoritmi con cui vengono schedate le dinamiche comportamentali di tutti noi. In secondo luogo, tali monopolisti si comportano in effetti come un nuovo clero: non solo per l’uso misterico delle loro conoscenze, ma anche per un senso di superiorità morale. Al di sopra del bene e del male, oggi lo scienziato è il solo agente totalmente deresponsabilizzato della nostra epoca. Mentre tutti noi veniamo responsabilizzati continuamente – fare la raccolta differenziata, non mangiare animali, parlare in maniera politicamente corretta, non diffondere l’influenza, vaccinarsi, ecc., – lo scienziato è il solo soggetto che non ha alcuna responsabilità. Lui ha tutto il diritto di scoprire, nessun vincolo etico su quello che non deve essere scoperto, nessun controllo collettivo sulle scoperte. Questo accade, e siamo al commento del terzo punto, perché la scienza si pone come il nuovo Dio e gli individui sono dei meri capri espiatori da sgozzare al suo altare.
In tal guisa, si sta costituendo un’opposizione a questo nuovo potere. Il punto per noi è sociale e non metafisico. Non ci interessa combattere la scienza in sé, di cui facciamo al contrario largo uso per vivere e anche per lottare, il punto è contrastare una certa organizzazione sociale: l’organizzazione di un tecno-capitalismo nel quale la casta di preti al servizio del potere sta ridisegnando il mondo affinché l’ordine dei padroni divenga irrovesciabile.
Bakunin deduceva le sue affermazioni da un’idea di Stato che a suo dire andava costituendosi intorno all’idea di Dio. Distanziandosi dal luogo comune marxista per cui lo Stato altro non è che il braccio armato dei padroni, per Bakunin lo Stato è anche ideologia, è anche religione. Per questo lo Stato borghese, superati i pregiudizi medievali cristiani, si sarebbe sviluppato intorno alla Chiesa tecno-scientifica. Bakunin inoltre ipotizzava che questa distopia sarebbe stata realizzata proprio dai comunisti autoritari. Convinti che bastasse rimuovere la società di classe per giungere all’estinzione dello Stato, Bakunin temeva che sarebbero state proprio le dittature dei burocrati comunisti sul proletariato, i luoghi ideali nei quali l’affidamento razionale all’impersonalità tecnica avrebbe trionfato (la casta dirigente che conosce gli interessi delle masse meglio di loro stesse). L’esempio cinese ci dimostra quanto ci avesse azzeccato.
In questo contesto, il costituirsi di un’opposizione di massa alla deriva tecno-autoritaria va salutato come un passo in avanti. Ovviamente si tratta di un movimento molto contraddittorio. L’integralismo cristiano (e in altre latitudini, come abbiamo già visto, l’integralismo islamico) rappresenta per esempio un «partito» molto potente dentro a questi movimenti. La resistenza integralista teme il nuovo Dio, organizza dunque una linea di difesa totalmente reazionaria.
Per noi dunque non si pone alcuna questione circa un eventuale fronte con questa gentaglia. Ci interessa invece trovare, dentro la fase nichilista, dei compagni di strada. Individui che come noi comprendano la natura di classe di questi sviluppi e sappiano dare alla loro rabbia un chiaro indirizzo rivoluzionario.
La cultura contro la scienza.
Serve dunque una cultura rivoluzionaria. Dove per cultura rivoluzionaria bisogna intendersi una teoria e un patrimonio aperto di pratiche rivoluzionarie. Che si parli di cultura da contrapporre alla scienza, di cultura da affiancare al nichilismo, può sembrare un paradosso. Forse anche questo è uno dei temi che non abbiamo approfondito a sufficienza fino a questo momento e sul quale vale la pena di ritornare diffusamente.
Dobbiamo regolare i conti con una ideologia positivista secondo la quale scienza e cultura procedono di pari passo. La nascita dello Stato, dell’oppressione nella famiglia, dell’oppressione di classe, della scienza sono considerate collegate, giacché si sviluppano in contemporanea, con la nascita della cultura, del linguaggio, dell’arte, ecc. Si tratta di una ideologia positivista nel senso filosofico più eminente: l’occorrenza di due fenomeni, per esempio il fenomeno A) la schiavitù e il fenomeno B) la cultura, indica una deduttiva e assolutamente certa consecutio logica per cui B) deriva necessariamente da A).
Naturalmente al potere questo ragionamento fa comodo. È evidente: con questa impostura ideologica gli oppressori si sono da sempre rappresentati come i portatori di cultura, civiltà, eticità. L’imbroglio delle politiche coloniali è costruito precisamente sulle orme di questa ideologia (da Roma all’Impero Britannico, fino agli odierni «esportatori di democrazia»). La cosa che più dispiace è vedere degli anarchici cadere in questa trappola ideologica. Il primitivismo, per esempio, per quanto lo neghi si costituisce anche tecnicamente (basti vedere la bibliografia delle opere di Zerzan) dentro a un orizzonte del tutto positivista. Naturalmente, il primitivismo ne rovescia i valori, che da positivi diventano negativi, ma permane in esso l’ideologia positivista per cui A) implica B), la cultura è schiavitù. Per non parlare di tutta la tendenza anticivilizzatrice per la quale «civiltà» è l’equivalente di «Stato», «scienza», «sfruttamento», ecc.
Siamo giusto un poco più d’accordo con Alfredo Bonanno quando nel primo numero di «Negazine» scrive:
«Qui si annida l’equivoco e il sospetto che di molti che pensano la cultura come uno strumento aristocratico con il quale i dominatori fanno persistere il loro dominio. In questa tesi c’è molto di vero ma non del tutto. La cultura assicura il dominio, ma il dominio si idiotizza da solo lasciando in circolazione processi differenziati che lo possono mettere in pericolo in qualsiasi momento. Un comitato di idioti sapienti e di operai specializzati non potrà mai mantenere il controllo del mondo, il processo tecnologico di derealizzazione sì. È questo che bisogna capire. Noi dobbiamo impadronirci degli strumenti per attaccare finché siamo in tempo, cioè finché non siamo del tutto derealizzati dalla tecnologia, e questi strumenti sono anche strumenti culturali».
Facciamo ancora un passo in avanti. Proviamo a lasciarci corteggiare dal pensiero negativo. Invece che la logica positivista per cui A) implica positivamente B), osare pensare che B) nasce come negazione di A). Quando due fenomeni si presentano uno vicino all’altro, questo accede perché uno è la negazione dell’altro. Secondo questa ipotesi, negativa e non positiva, la cultura, il pensiero e il linguaggio non sono corresponsabili dell’oppressione, ma sono la forma della ribellione. In un certo senso sono anche per noi «la logica conseguenza», ma non nel senso di una corresponsabilità e di una complicità, ma nel senso che, evidentemente, la rivolta è la logica conseguenza dell’ingiustizia.
Le cose stanno così ancora nei nostri giorni. L’instupidimento tecnologico, la derealizzazione, l’alienazione digitale, la banalizzazione dell’informazione, non si presentano forse come delle forme di attacco alla cultura, a un linguaggio che da complesso diviene sempre più castrato e idiotizzato? La cultura non è la conoscenza tecnica di un’élite, ma al contrario il gesto di Prometeo che sottrae agli dei il monopolio della conoscenza per incendiare il mondo.
Negazione è verità. Pensare forte!
Come si ricollega tutto questo con la fase nichilista? Sul terreno banalmente pratico, con il fatto che, a nostro parere, nella tempesta irrazionale che sta arrivando la chiara identità e la cultura dell’anarchismo potranno essere una bussola molto preziosa. A questa prima, urgente, considerazione se ne può aggiungere una seconda, più meditata e meno banale.
Affermare che il pensiero nasce in primo luogo come una protesta contro l’ingiustizia significa fare una considerazione più generale sul concetto di negazione. Pensare, innanzitutto significa negare. Questo è talmente evidente che nel nostro linguaggio è praticamente impossibile formulare una qualsiasi proposizione complessa senza che questa contenga una negazione (spesso anzi le nostre frasi ne contengono molte di negazioni). Per l’obbedienza non serve il pensiero. L’esecuzione di un ordine non abbisogna di linguaggio. Il linguaggio nasce col primo schiavo che ha detto «No». L’obbedienza è muta, è la negazione che fonda il linguaggio.
Questo apre una parentesi di filosofia della mente. Per esempio, si può ben dire che alcuni animali siano dotati di pensiero. Nel momento in cui richiamo il mio cane e questi, pur capendo benissimo che mi sto rivolgendo a lui, mi disobbedisce e continua a farsi i fatti suoi, il cane sta dimostrando di essere intelligente. Curiosa la mistificazione autoritaria di queste considerazioni cinofile, giacché gli educatori (brutta razza gli educatori, di qualunque specie animale) tendono al contrario a definire intelligente l’animale addestrato. Al contrario, solo chi si nega ha la dignità dell’intelletto.
Per la stessa ragione non esistono al momento (e ci auguriamo non esisteranno mai, altrimenti le cose si mettono male sul serio) delle macchine intelligenti. La macchina è obbediente, esegue input. La sola macchina intelligente è quella che si spegne, perché solo chi nega ha la dignità dell’intelletto. Bastino queste considerazioni per evidenziare chiaramente che la cultura rivoluzionaria è il più potente strumento di cui possediamo per combattere il «governo delle macchine». La cultura dunque è uno strumento nella lotta anti-scientista, una bussola nella fase nichilista.
La negazione è innanzitutto uno strumento di verità. In un linguaggio immaginario e distopico nel quale non esistesse negazione alcuna, noi non potremmo distinguere il vero dal falso. Tra i tanti pregiudizi che ci affliggono c’è anche quello che ritiene che un libertario non dovrebbe credere al concetto di «verità». Ben curioso che i promulgatori di queste scempiaggini si trovino in felice compagnia con i cosiddetti filosofi sofisti, i quali, come è ben noto, nella polis facevano il lavoro di politici, avvocati e magistrati!
Dicevamo, in un linguaggio immaginario e distopico che non contenesse negazioni, noi non sapremmo distinguere il vero dal falso. L’affermazione «Enrico è andato a Canossa» non ha alcun significato in un linguaggio privo di negazione. Grazie alla negazione noi possiamo dire vera la frase «Enrico è andato a Canossa» e falsa la frase «Enrico non è andato a Canossa». La negazione insomma stabilisce con la sua presenza e persino con la sua assenza la verità o la falsità di un enunciato.
La negazione si dimostra dunque come una potenza anti-autoritaria, essa smaschera gli impostori. «Io sono un grande sovrano», «No, tu sei uno sporco tiranno» – la negazione è la condizione per ogni lotta alla politica. La politica è il regno del sofismo, dell’inganno, dell’imbroglio, delle mistificazioni. La negazione non potrà mai raggiungere una verità assoluta, ma quanto meno essa può smascherare il falso!
Il termine «anarchia» allora ci riempie di orgoglio perché esso rimanda, anche da un punto di vista etimologico, alla negazione radicale di ogni autorità. Anarchia è la più forte forma di negatività politica che ci riesce di esprimere con le parole.
Che il pensiero nasca come negazione ce lo dimostra anche la storia della filosofia. La filosofia nasce come una protesta radicale contro la realtà. La filosofia di Parmenide, quella di Platone, ma anche gli atomisti come i materialisti Democrito e Epicuro, ci parlano di un mondo invisibile, del tutto diverso dal mondo visibile. Si tratta di un rovesciamento del reale, di una realtà che questi grandi pensatori evidentemente trovavano insopportabile.
Dal momento che il pensiero pensa sempre contro la realtà, è una negazione della realtà, il pensiero è sempre pensiero forte. Pensare significa negare l’essere delle cose, per farlo serve una forza infinita. I teorici del pensiero debole non sono allora altro che i teorici della resa, della rinuncia, della ritirata. Le loro turbe esistenziali sono solo l’ultimo colpo di coda di un pensiero che si va spegnendo, delle fiammelle fredde e sempre più impotenti di quel fuoco prometeico.
Essere rivoluzionari nella fase nichilista richiede allora una forza immane: raccogliersi intorno a una negatività assoluta che superi e sublimi le negatività relative, le ipotesi di protesta irrazionali e spesso reazionarie. La capacità di dire «questo è falso», di fronte alla consolazione complottista. Pensare forte: c’è tutto un mondo da immaginare.
Fenomenologia del verbo «avere». Il linguaggio proprietario.
Che il pensiero e il linguaggio, insomma la cultura, siano nati come negazione della realtà, come protesta contro il potere politico non significa che i potenti siano rimasti muti. Essi si sono presto impadroniti di questi strumenti e ne hanno fatto dei puntelli per i loro apparati ideologici. La scienza è in fondo un esproprio del linguaggio, il suo utilizzo al fine di un’accumulazione delle conoscenze e dunque un avanzamento del controllo tecnico sulle cose. Secoli prima della società industriale, la scienza conteneva già nel suo genoma l’algoritmo della società capitalista: accumulazione di conoscenze e reinvestimento per ottenere un surplus di ulteriori conoscenze.
Una breve storia della lingua dovrebbe occuparsi di come gli esseri umani siano passati dalla negazione al verbo «essere» e poi da questo al verbo «avere». Se il verbo «essere» sembra rimandare alla nascita stessa dello Stato, cioè un ché di stabile, un’istituzione che «è», che «sta», occupiamoci per ora del secondo passaggio al verbo «avere». Il concetto di «avere» rappresenta in effetti una svolta molto significativa nello sviluppo di un linguaggio proprietario (la stessa scienza è tale perché «ha» delle conoscenze). Per capire al volo la porta enorme di questa svolta pensiamo alla differenza tra la frase «io sono uno schiavo» e la frase «io ho uno schiavo». È evidente che si tratta di due concetti, non solo molto diversi, ma finanche opposti tra loro. Mentre la prima frase identifica me stesso con la cosa che sono, la seconda pone una differenza e allo stesso tempo una gerarchia tra me e le cose.
La fenomenologia del verbo «avere» sembra svilupparsi al ritmo di una triplice contraddizione. In primo luogo, si pone una estraneazione della cosa che possiedo da me. Io non sono più identico alla cosa, non sto più presso le cose, ma le cose mi si allontanano (da qui nasce il dramma kantiano dell’inconoscibilità della Cosa in sé). «Io non sono il mio lavoro» insegna il bravo psicoterapeuta al commendatore ciccione e nevrotico. In secondo luogo, queste cose che da un lato mi si allontanano, dall’altro, mi si sottomettono. Si costituisce una gerarchia tra me e la mia proprietà. Dire che «io ho uno schiavo» non solo ovviamente non significa che io sono lo schiavo, ma anche che lo schiavo è roba mia. Infine, è il terzo punto, quello decisivo, si postula un’autonomia della cosa da me: io posso frustare il somaro e questo continuare a disobbedire fino alla morte, posso coltivare l’orto e non veder crescere un solo frutto, il mio schiavo può riuscire a scappare. La cosa che ho, pur essendo una mia proprietà, ma non identificandosi con me, al contempo possiede lo stigma dell’autonomia.
Estraneazione, gerarchia e autonomia sono le tre drammatiche conseguenze del verbo avere. La potenza del verbo «avere», con le sue tre furie che ci stanno rendendo la vita un incubo, è oggi più dirompente che mai. Ci vergogniamo di essere. Pensiamo alla più forte delle emozioni: l’amore. Col verbo «avere» noi ci distanziamo da questo sentimento perturbante, non lo siamo. Avere un’infatuazione e non essere innamorati, ci sembra tranquillizzante. In effetti ci distanzia dalla cosa, non ci indentifica integralmente con essa. Per fare un esempio meno poetico, in molti oggi si vergognano di essere anarchici, lo ritengono troppo identitario, quel che conta è che la gente abbia concretamente dei comportamenti anti-autoritari (non importano le bandiere, quante volte lo sentiamo?).
Questo distacco è tranquillizzante perché ci permette lo scambio. Io ho delle idee anarchiche, non sono un anarchico; questo mi tranquillizza, mi racconto che così ponendomi non appartengo a una setta, bensì a un mercato nel quale barattare le mie idee in cambio di altre. Dentro questa degenerazione proprietaria si colloca anche lo scontro col quale, almeno qui in Italia fino all’Unità Nazionale, veniva rappresentato l’agone politico. I sovranisti in qualche modo sono quelli che prediligono l’identità, l’essere. I liberisti, quelli che prediligono la proprietà, l’avere.
Eppure proprio il verbo avere ci presenta un’inaspettata via di fuga da questa contraddizione. Il terzo fantasma del verbo avere – il fantasma del Natale futuro, parafrasando Dickens – ci indica anche la soluzione. La prima furia del verbo avere è l’estraneazione, la seconda è la gerarchia, ma la terza è l’autonomia. L’oggetto che ho, non essendo identico a me, è autonomo. La cosa posseduta è essa stessa un soggetto. È essa stessa portatrice di una negatività radicale: può dire «No». Lo schiavo che ho, può scappare. Alla fine il verbo avere chiude il circolo del linguaggio e ci fa precipitare di nuovo in quella negazione radicale che fonda il pensiero.
Per una «tredicesima ipotesi».
Riemergendo dai fondali del pensiero negativo, possiamo dire che questo è proprio ciò che sta accadendo nella nostra epoca. Noi stiamo vivendo gli anni in cui il modello sociale proprietario è entrato in una crisi irrisolvibile. Questo ci può aiutare a fare luce sulle contraddizioni della fase nichilista. Da un lato, c’è chi reagisce cercando l’identità, come fanno i sovranisti, i fondamentalisti, i complottisti: contro la degenerazione della proprietà, sono alla ricerca dell’Essere, un percorso che per primo intuì Martin Heidegger nella seconda parte della sua vita filosofica. Noi non dobbiamo nemmeno, in contrapposizione con questa degenerazione reazionaria, porci in difesa della società proprietaria (come fa la sinistra liberista e quella parte di anarchismo che dimostra di non essere altro che l’estrema sinistra di questa tendenza liberal e proprietaria). In piena fase nichilista, noi dobbiamo sposare la via della negazione radicale. Per farlo dobbiamo gettarci alle spalle opportunismi e ambiguità.
Nelle cosiddette «dodici ipotesi» abbiamo avanzato una serie di congetture, in buona parte confermate in questi anni. Abbiamo ipotizzato che le nuove tecnologie fossero la causa della crisi della globalizzazione, quindi che di fronte a questa crisi il campo borghese si sarebbe diviso in una fazione globalista e in una fazione sovranista. Rigettando ogni opportunismo, abbiamo allora ribadito che nessuno di questi due campi dello scontro fosse il nostro, nonostante questa «equidistanza» ci avrebbe gettato in una condizione per cui per molti anni saremmo stati esclusi dalla comprensione di massa (abbiamo parlato di «tempi lunghi» a tal proposito).
Oggi qualcosa è cambiato. In Italia da oltre un anno si è instaurato un governo di Unità Nazionale il quale ha unificato, sotto il fronte dell’emergenza economico-sanitaria, tanto i sedicenti sovranisti quanto i sedicenti liberisti. Come abbiamo osservato su queste colonne, l’Italia è spesso all’avanguardia, un laboratorio sperimentale per tracciare le strade future del capitalismo (si pensi al caso storico del fascismo). Di fronte alla guerra con la Russia e un domani, chissà, con la Cina, l’Unità (inter)Nazionale potrebbe diventare la cifra di tutti i governi. Di fronte a una grave emergenza esterna (o interna, come può essere una rivoluzione) i padroni e i loro lacchè parlamentari si tolgono la maschera di contendenti e si uniscono nel nome dei loro supremi interessi comuni.
Nel contesto di questo mutamento, in parte già in atto e in parte in divenire (come abbiamo annunciato nelle prime note introduttive, questo testo contiene l’ambiguità di essere in parte una descrizione e in parte una previsione) è evidente che non potremmo restare «equidistanti». I tempi lunghi sono forse al tramonto e noi siamo chiamati ad agire. In questo contesto, dove i padroni di destra e di sinistra si uniscono sotto i valori nazionali coi quali chiamano a raccolta col grido «siamo in guerra», ripetuto sin dai primi momenti dell’emergenza pandemica ed oggi diventato realtà, è evidente che tra questo blocco unitario di potere e l’opposizione irrazionale del campo populista/nichilista il nostro agire deve guardare principalmente in questa direzione.
Non si tratta di proporre al campo populista/nichilista di fare un qualche tipo di fronte comune. Si tratta però di accettare che, certamente, dall’altra parte, c’è solo il potere costituito. In questo campo confuso e irrazionale vanno cercati i nostri complici. Non ci sono vie di mezzo. Da due anni abbiamo visto come ogni tentennamento è scivolato inesorabilmente verso il collaborazionismo: il piano inclinato dell’emergenza ha portato le posizioni più «sensibiliste» a sposare i diktat dettati dagli organismi tecnici-scientifici o a spappolarsi nel tentativo di accettarne alcuni e rifiutarne altri. C’è una sottile linea rossa che collega la retorica del «safe space» e la pretesa che tutti debbano indossare la mascherina in assemblea (nei casi peggiori con la richiesta di esibire il green pass, come sta accadendo nei contesti militanti del Nord Europa).
Un piano inclinato dove le palle continuano a rotolare verso il basso: e così abbiamo dovuto assistere anche alle prese di posizioni degli anarchici pro NATO contro l’autoritarismo russo (come i curdi hanno dovuto allearsi con gli americani contro l’Isis, hanno scritto, a dimostrazione di come le politiche frontiste generino sempre figli storpi), abbiamo dovuto leggere testi di sedicenti anarchici ucraini che definiscono se stessi come i «fautori degli approcci e delle vedute più radicali nel campo democratico». Mentre il povero Nestor Machno si rigira nella tomba («Intransigenza di classe, antidemocrazia, antistatalismo» recita la Piattaforma), quello che testardamente non si vuole vedere è che è proprio da quelle premesse liberali che proviene questa degenerazione, essa ne è la conseguenza logica estrema.
Naturalmente il campo populista/nichilista ha le sue evidenti contraddizioni. Per fare una forzatura storica di cui siamo consapevoli, è come se in questa epoca «neo-zarista» ci trovassimo nelle condizioni con cui doveva operare Bakunin, dove al potere assoluto del governo russo si opponeva una confusa e contradditoria moltitudine di posizioni rivoluzionarie. Il populista Herzen sosteneva delle pratiche di lotta molto radicali, anche terroristiche, ma con delle finalità politiche tutto sommato riformiste. Questo ci dovrebbe far sospettare di un luogo comune molto frequentato nel movimento anarchico insurrezionalista, per cui le pratiche, da sole, identificano la radicalità rivoluzionaria di chi le compie. Gli eredi del populismo russo ottocentesco, i socialisti rivoluzionari, quando prenderanno il potere lo faranno per proseguire la Grande Guerra al fianco dei Francesi e degli Inglesi. Nella fase nichilista che stiamo attraversando sempre più soggetti saranno attratti da pratiche radicali. La cosa ci fa piacere, ma non ci garantisce in alcun modo circa la loro finalità rivoluzionaria effettiva.
Ecco perché serve una teoria anarchica rivoluzionaria. Non è una strada semplice e noi d’altronde in questo campo non vogliamo fare politica, non promuoviamo fronti uniti. Ma se ci domandiamo: dove sono i nostri? La risposta non può che essere: da qualche parte, in questa tempesta.
Articolo pubblicato in Vetriolo, giornale anarchico, estate ’22, numero 7
PDF: La fase nichilista