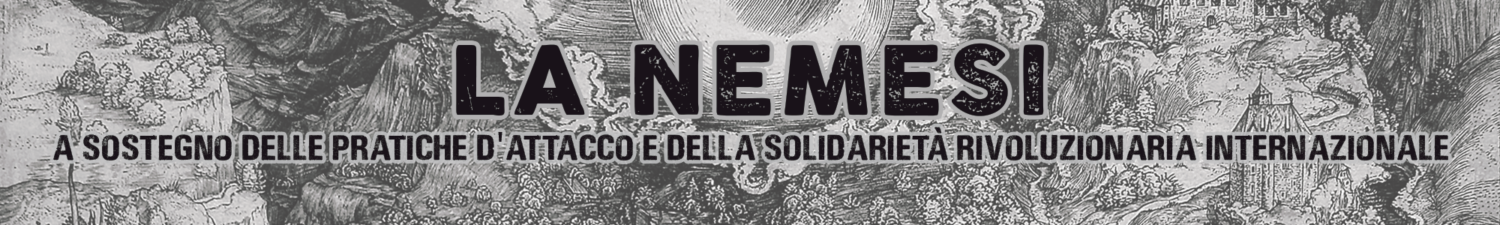Insurrezione e comunizzazione: ripensare l’emancipazione sociale radicale in una nuova epoca di catastrofi
Introduzione del traduttore
Pochissime parole introduttive su questo testo estratto e tradotto da Nec plus ultras1: un blog cileno creato a seguito del riflusso della rivolta avvenuta in Cile nel 2019, in cui sono raccolti, oltre ad una serie di contributi procedenti dalla necessità di redigere un bilancio critico di quella sollevazione e dei suoi esiti, una serie di scritti riconducibili alla teoria della comunizzazione, nonchè analisi inerenti le guerre in corso, gli sviluppi e le svolte del capitalismo in America Latina e negli USA.
I contributi più interessanti riguardano le possibilità di rottura insurrezionale emergenti a tutte le latitudini del globo, a partire dalle contraddizioni, dalle crisi e dalle crepe interne al modo di produzione capitalistico.
Da queste stesse premesse prende le mosse Insurrezione e comunizzazione, redatto nei primi mesi del 2024 che, al di là dei numerosi limiti riscontrabili e delle critiche alla sua impalcatura metodologica e analitica, da impostare e sviluppare, ha il merito di affrontare questioni assai spinose, sintetizzabili in pochi interrogativi fondamentali e imprescindibili per i rivoluzionari di oggi, tra questi: quali sono i presupposti di un processo insurrezionale, e che misure immediate sarà necessario prendere perché esso non venga rapidamente sconfitto dalla repressione o dal recupero da parte delle classi dominanti, spianando la strada al ritorno della normalità capitalistica, col suo surplus di oppressione e controrivoluzione preventiva? È possibile pensare ad una rottura rivoluzionaria mettendo da parte la necessità primaria per gli insorti di riprodurre prima di tutto la propria esistenza fisica e sociale facendo a meno delle mediazioni classiche del vecchio mondo e delle sovrastrutture capitaliste? E ancora, se l’assunzione di tale necessità passa attraverso la riappropriazione delle forze produttive ed il reindirizzamento della produzione diretta al soddisfacimento dei bisogni e dei desideri degli insorti (senza scambio di equivalenti e di valore), in che termini occorrerà fare i conti con le macchine, le infrastrutture, le materie prime, le energie su cui si fondava la produzione industriale capitalista?
Va precisato che è stato ritenuto opportuno eliminare la parte finale dello scritto, in quanto la sua traduzione non avrebbe apportato nulla in più alle tesi fondamentali sviluppate e più volte riprese, spesso eccessivamente e fastidiosamente, nel corpo del testo. Sono stati quindi tagliati i ringraziamenti dell’autore ad una serie di compagni e compagne che hanno stimolato le riflessioni trasposte poi per iscritto e le anticipazioni delle tematiche trattate nella seconda parte di questo stesso contributo, che verrà prossimamente tradotta in italiano e resa disponibile.
1 https://necplusultra.noblogs.org/
Insurrezione e comunizzazione:
ripensare l’emancipazione sociale radicale in una nuova epoca di catastrofi
Viviamo in un’epoca di catastrofi che farà presto impallidire quelle del XX secolo. La civiltà del capitale ha subito una disfatta socio-ecologica che si manifesta in differenti aree del pianeta, esplicitando il vero carattere della presente e inedita era di sofferenza socialmente esacerbata.
A Gaza si consuma un genocidio nel quale si combinano forme estremamente specifiche di distruzione dell’essere umano, che fanno uso della tecnica iper-moderna assieme ai più atavici metodi del terrore. Come soleva dire Guy Debord: «ciò che è più moderno è anche ciò è più atavico».
Ma l’incendio rappresentato dal collasso della civiltà capitalista si estende oltre la forma della guerra neoimperialista: dagli squadroni della morte della droga divenuti potenze transnazionali, fino ai veri e propri incendi forestali, nel contesto di un aggravato riscaldamento globale, che origina dalla distruzione della natura perpetrata dalla produzione capitalistica di merci.
Si afferma dunque giustamente che Gaza è il mondo; lì si riuniscono, convergono e si giustappongono tutti i molteplici fattori della crisi capitalista che da un preciso punto del pianeta-capitale mostrano l’esatta immagine del collasso prossimo futuro del vigente modo di vita socialmente alienato. Non è quindi un caso che il 2023 passerà alla storia come l’anno più caldo e più violento mai registrato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Del resto, tutto il mondo sta sprofondando in una violenza portata all’estremo. Le fragili barriere alla violenza senza controllo che, dopo le guerre mondiali ed i processi di decolonizzazione, la civiltà borghese ha posto dinnanzi a se stessa, hanno finito per crollare ancora una volta a Gaza. D’ora in poi la vecchia narrazione democratica e dei diritti umani rivendicata dalle potenze principali del neoimperialismo occidentale non farà che perdere quel poco di senso propagandistico che poteva conservare, tanto che nemmeno i suoi difensori più convinti potranno nulla per difenderla.
Con questo, nella crisi della civiltà borghese avanzata, si spalanca il cammino alla guerra totale e realmente mondiale; una guerra neoimperialista planetaria tra grandi blocchi di potenze capitaliste che già oggi si scontrano sempre più apertamente in differenti zone del pianeta. Inoltre, laddove la sovranità dello Stato capitalista arretra o tende a collassare repentinamente, come nel caso della Somalia o del Congo, non si verifica alcuna emancipazione, giacché lo spazio vuoto lasciato dallo Stato viene occupato da nuovi rackets transnazionali e dai loro squadroni della morte.
Oggi, senza timore di cadere in errore, è possibile riformulare la celebre affermazione contenuta nella prefazione a Il Capitale: le zone alla periferia del mondo mostrano alle nazioni industrialmente più avanzate l’immagine del proprio terribile futuro. Il caso dello Stato dell’Ecuador, recentemente destituito dalla guerra tra rackets statali e parastatali, e quello del Messico, dove il narco permea tutti i livelli della struttura sociale divenendo potenza transnazionale, sono paradigmatici del contesto dell’America Latina; così come El Salvador, col suo nuovo modello di principe emerso nel corso della crisi: Nayib Bukele.
Non dovrebbe dunque stupirci che, in determinate condizioni capitalistiche, con una crisi globale capace di ridurre centinaia di milioni di persone al limite della sopravvivenza, parallelamente ad un accumulo di ricchezza sconvolgente, si faccia ricorso ad un nuovo tipo di autoritarismo, che non promette nemmeno più ai suoi sventurati cittadini di non morire di fame, bensì di non rischiare la fucilazione.
In questo contesto, tutte le varianti della sinistra progressista hanno fallito su scala mondiale nell’amministrare il capitale, e da nessuna parte sembra profilarsi alcun orizzonte d’emancipazione realmente alternativo alla catastrofe capitalista. A tal proposito, forse nessuno ha mai compreso meglio di Walter Benjamin che in tutto il suo divenire storico il quadro della socializzazione capitalista è caratterizzato dalla catastrofe e dalla disperazione, e che, per questo, l’emancipazione sociale radicale non può consistere in altro che nell’attivazione di quel freno d’emergenza capace di arrestare l’avanzata del movimento del capitale verso il completo autoannichilimento.
Del resto, che la conclusione logica di tale dispiegamento sia proprio la completa autodistruzione dell’umanità è certamente qualcosa di terribile e realizzabile non solo comprendendo criticamente le dinamiche fondamentali del movimento del denaro come capitale, ma analizzando attentamente le condizioni d’esistenza che caratterizzano la storia di questa civiltà. Allora, in che cosa consiste questo freno d’emergenza e come può consentirci di ripensare all’emancipazione sociale radicale? Più avanti sosterrò che la teoria della comunizzazione costituisce un valido strumento di autochiarificazione della possibilità radicale che emerge dalle lotte sociali contemporanee. Effettivamente, come vedremo, è proprio la dinamica contraddittoria delle forme sociali capitaliste a permettere non solo di criticarle sul piano teorico, ma anche di negarle praticamente. La teoria della comunizzazione è dunque un’espressione della negatività presente nell’intero arco sociale capitalistico.
Ciò che qui mi interessa non è tanto fare un’apologia acritica di una determinata teoria, quella della comunizzazione, quanto piuttosto contribuire allo sforzo, ancora frammentario, di elaborazione di una teoria critica radicale di carattere autoriflessivo. Solo all’interno di questa cornice, quella di una critica sociale radicale da intendersi come possibilità della società dalla quale emerge, può aver senso il dialogo con la teoria della comunizzazione. Perciò mi preme mettere in luce il carattere pratico dell’abolizione del valore, che di fatto costituisce la grande questione della teoria rivoluzionaria contemporanea, e, ancor di più, chiarire la possibilità d’emergenza di una pratica rivolta coscientemente alla soppressione delle forme sociali capitalistiche.
In altre parole, il confronto critico con la teoria della comunizzazione qui impostato ha come obiettivo quello di riflettere sulla possibilità di una critica pratica della socializzazione capitalistica. Un approccio che implica ovviamente la non assunzione da parte della suddetta teoria della determinazione definitiva dell’emancipazione umana, ma, al contrario, l’affermazione di un parziale momento di autochiarificazione circa le opportunità pratiche in movimento all’interno del presente stadio storico della civiltà capitalista.
Innanzitutto, si tratta di una manifestazione delle reali potenzialità delle lotte contemporanee, che in quanto tali non coincidono con l’emancipazione sociale, bensì costituiscono un momento, nella formazione sociale attuale, di una critica sociale radicale, ancora frammentaria.
Com’è già possibile constatare, la possibilità di una critica pratica del capitale non è, chiaramente, il risultato di alcuna teoria particolarmente brillante – nonostante la teoria, in quanto autochiarificazione, implichi lo sviluppo delle potenzialità soggettive – o della capacità di analisi di menti altrettanto geniali; essa è il prodotto delle trasformazioni materiali e storiche della civiltà capitalista avanzata e del conseguente sconvolgimento del suo quadro di socializzazione.
Come qualsiasi persona interessata potrà verificare autonomamente, la teoria della comunizzazione è venuta alla luce a seguito delle rivolte globali del 1968 e della manifestazione di un nuovo carattere qualitativo della lotta di classe, frutto della crisi, e del successivo collasso, del vecchio movimento operaio, nonché della specifica configurazione del quadro della socializzazione capitalistica, di cui tale movimento costitutiva parte integrante, fattore di modernizzazione, ma anche possibilità di critica immanente, volta al suo superamento.
La teoria della comunizzazione – questo punto la rende una corrente di particolare rilevanza per la critica radicale contemporanea – è una teoria autocosciente della propria determinazione socio-storica: comprende se stessa in quanto bilancio critico della disfatta dell’ondata rivoluzionaria 1968-1977, e, come tale, della formazione di un nuovo paradigma delle lotte di classe e dell’emancipazione sociale.
Non entrerò qui nel merito delle mie divergenze teoriche rispetto a questa teoria, in particolare alla sua comprensione della storia della civiltà capitalista, alla la sua teoria dell’ideologia – in special modo quella di Théorie Communiste – piuttosto che al suo mancato confronto con la ”nuova lettura di Marx”(Neue Marx-Lektüre), perché credo che il suo merito risieda nella sua stessa esistenza e nel fatto di sottolineare il carattere pratico del movimento di abolizione del valore come processo di autotrasformazione della società, da cui deriva la soppressione del proletariato.
Nonostante il suo linguaggio necessariamente esoterico, la teoria della comunizzazione può e deve essere considerata a pieno titolo come una nuova lettura di Marx che rifugge dall’ambito accademico, ma che condivide punti di convergenza fondamentali con altri apporti teorici proveniente da tutto il mondo, il cui orientamento prevede essenzialmente la costituzione di una teoria sociale radicale capace di tramutarsi in forza materiale e storica diretta alla soppressione/superamento del quadro della socializzazione capitalistica.
Insomma, non ho alcuna intenzione di riassumere in modo dettagliato gli apporti di questa teoria – frammentaria e composta da differenti collettivi ed individualità dalle prospettive spesso divergenti –; voglio rimarcare invece la possibilità di un’insurrezione contro la forme capitalistica dei rapporti sociali, un’insurrezione tesa a minare le forme sociali fondamentali che sostengono l’intero edificio della socializzazione capitalistica.
Più avanti, spiegherò come questa possibilità, lungi dall’essere un abbaglio teorico, costituisca la dimensione radicale delle lotte di classe del presente e la base materiale dell’esistenza della teoria della comunizzazione.
Comunizzazione
Quando Theorie Communiste afferma che la rivoluzione corrisponde alla comunizzazione intende dire che essa può svolgersi solo in quanto processo di autotrasformazione materiale della dinamica sociale, nel cui dispiegamento il valore, forma dei rapporti sociali, tende ad essere negato praticamente; da questa stessa negazione tale processo acquista la propri forza. Più semplicemente, la comunizzazione designa un processo pratico collettivo attraverso il quale la forma capitalistica dei rapporti sociali viene abolita nell’azione [insurrezionale], cioè sopprimendo lo scambio di merci, il valore, il denaro, il lavoro, il capitale e, ovviamente, lo Stato – il cui fondamento risiede proprio nelle forma capitalista dei rapporti sociali – e il patriarcato – nella misura in cui i rapporti capitalistici non sono neutre rispetto al genere -; la loro abolizione corrisponde all’abolizione del genere così com’è stato socialmente prodotto da questa civiltà.
In tutte le sue varianti, la teoria della comunizzazione ha sempre insistito sulla possibilità dell’immediatezza del comunismo, cioè della produzione immediata di un modo di vivere emancipato socialmente, a partire da una rottura pratica con la socializzazione capitalista, da essa derivante, come sua critica immanente in azione. Evidentemente, la sola considerazione di tale possibilità costituisce in sé il risultato di un processo storico della civiltà capitalista, una trasformazione materiale dei rapporti del capitale, in cui l’emancipazione sociale non si verifica sulla base dell’affermazione del proletariato in quanto classe – e a sua volta quella del capitale, [essendo il primo presupposto del secondo] – bensì della sua negazione, della messa in discussione di se stesso e delle proprie azioni, in quanto classe parte della socializzazione capitalista.
Come sosteneva Amadeo Bordiga, il comunismo era certamente possibile sin dal 1848, però sulla base dell’affermazione del proletariato come classe. Con questo non voglio dire che l’abolizione della società di classe fosse impossibile per l’arco storico in cui la lotta di classe, nella storia del movimento operaio, si verificò.
L’emancipazione sociale radicale non costituisce alcuna forma di invariante storica, piuttosto il risultato di una produzione storica reale che ha luogo all’interno del metabolismo sociale capitalista. Non essendo un’astrazione immutabile, un ideale normativo, essa si sviluppa sempre sulla base del dispiegamento storico della dialettica della merce propria della civiltà capitalista, e quindi della lotta di classe.
La lotta di classe del movimento operaio ha rappresentato una possibilità di emancipazione durante un determinato arco storico della civiltà del capitale. Il consiglio [soviet], l’autogestione, lo sciopero generale di massa, la presa del potere, ecc., costituivano forme pratiche di tale possibilità, nella misura in cui, all’interno del rapporto capitalistico, ossia quella tra capitale e classe salariata – fondamento del valore che si valorizza – l’autoemancipazione del proletariato poteva unicamente realizzarsi come affermazione della classe. Infatti, nel processo storico di transizione dal dominio formale a quello reale del capitale, la lotta di classe operaia, acquisiva per forza il contenuto e la forma della propria affermazione di classe del capitale interna alla socializzazione capitalista, poiché la lotta contro il capitale era determinata dalla riproduzione della classe operaia come momento necessario della riproduzione allargata.
Oggi, nella transizione globale verso la quarta rivoluzione industriale, la situazione è radicalmente differente. La riproduzione della classe operaia mondiale non è più il presupposto necessario della riproduzione allargata del capitale, che ha razionalizzato l’insieme del processo produttivo di merci. Essa dipende sempre meno dal costo immediato del lavoro umano astratto misurato in unità di tempo; una tendenza che, tra i vari aspetti, si esprime nella produzione di enormi masse di popolazione eccedente per il capitale e nella sottoproletarizzazione della classe operaia.
Questo comporta l’emersione di qualsiasi movimento di opposizione sociale radicale all’interno della civiltà capitalista come critica immanente della presente forma alienata di interdipendenza sociale, derivante da quelle stesse forme di socializzazione ed è in contraddizione con esse. Tuttavia, è da evidenziare come sia proprio il carattere contraddittorio di queste forme a costituire la condizione di possibilità della critica sociale radicale. Se la forma merce fosse l’ultima forma di riproduzione sociale, se coincidesse completamente con i soggetti della socializzazione – nel tardo periodo della sua produzione teorica Camatte suggerisce esplicitamente, a mio modo di vedere sbagliando, che questa identità sia stata realizzata nell’antropomorfosi del capitale – allora non sarebbe possibile alcune critica né negazione pratica di questa forma storicamente determinata di rapporti sociali. Al contrario, posto che la forma merce in quanto forma particolare della ricchezza capitalistica è in se stessa contraddittoria, al contempo materiale e astratta, nel suo dispiegarsi storico è contenuta la possibilità della sua critica e del suo superamento. Di conseguenza, il comunismo non è un ideale normativo e nemmeno un’essenza invariante da realizzare, ma la formula necessaria dell’emancipazione sociale come produzione storica.
La critica marxiana dell’economia politica afferma la possibilità del comunismo come critica immanente dei rapporti sociali capitalistici, tuttavia tale rottura è essa stessa produzione storica facente parte del quadro di socializzazione.
L’emancipazione sociale radicale come comunizzazione presuppone che le lotte sociali del presente, e la guerra di classe, abbiamo come forma necessaria la produzione immediata di relazioni sociali svincolate dalla legge del valore; una produzione la cui condizione di possibilità risiede nella grandissima quantità di tempo storico in cui l’attività produttiva, sotto il regime di spoliazione e sofferenza proprio della produzione di merci, si è oggettivata. Ciò vuol dire che la riappropriazione del tempo storico da parte della masse salariate – che nei Grundrisse di Marx rappresenta il contenuto stesso dell’emancipazione radicale – non si verifica in un contesto immobile, sempre uguale a se stesso; è nella dinamica storica della produzione capitalista che essa trova la sua condizione di possibilità.
Quando faccio riferimento alla comunizzazione come ad una critica pratica dell’economia politica, intendo rimandare alla trattazione di un movimento reale in marcia che nega la forma capitalista [di appropriazione privata] del prodotto sociale, per porre in risalto la disponibilità di tempo – emancipazione del tempo di vita dai rapporti capitalistici – come ricchezza. Ma ciò non sarebbe possibile se l’esito della produzione capitalista – la produzione di plusvalore – non fosse allo stesso tempo produzione di plus-tempo storico oggettivato come plusvalore, unica sua forma possibile d’esistenza e permanenza, e come tempo eccedente oggettivato e accumulato come capitale, nella misura in cui si realizza sistematicamente la riproduzione allargata del capitale. Quindi, la ricchezza nella forma capitalista – ricchezza astratta, valore – può rimanere tale solo se si rinnova continuamente dispiegandosi storicamente, laddove nel suo stesso dispiegamento sta la sua negazione; ne deriva naturalmente che, per ricostituirsi continuamente, il capitale deve riprodurre il proletariato come tale, rinnovando la separazione dei produttori dagli strumenti della riproduzione sociale, compresa la terra, riproducendo costantemente la loro dipendenza e i loro bisogni in rapporto al capitale.
Come sempre, una digressione di Marx sulla ricchezza chiarifica enormemente la questione:
«In fact, però, se la si spoglia della limitata forma borghese, che cos’è la ricchezza, se non l’universalità dei bisogni, della capacità dei godimenti, delle forze produttive, degli individui, generata nello scambio universale? Cos’è, se non il pieno sviluppo del dominio dell’uomo sulle forze naturali, sia su quelle della cosiddetta natura, sia su quelle della sua propria natura? Cosa, se non l’elaborazione assoluta delle sue capacità creative, senza altro presupposto che lo sviluppo storico precedente, che fa di tale pienezza totale di sviluppo, quello di tutte le forze produttive umane in quanto tali, non misurato con uno schema prestabilito, l’obiettivo? Che cosa se non un’elaborazione in base alla quale l’uomo non si riproduce nel suo carattere determinato, ma produce la sua pienezza totale?
Nell’economia borghese – e nel modo di produzione corrispondente – questa piena elaborazione appare come totale svuotamento, questa oggettivazione universale come alienazione totale e la distruzione di tutti gli obiettivi determinati unilateralmente come sacrificio del proprio scopo ad uno completamente esterno (…). È soddisfazione solo da un punto di vista limitato, mentre il mondo moderno lascia insoddisfatti, o, quando è soddisfatto di se stesso, lo è solo volgarmente».
Per comunizzazione potremmo allora intendere il movimento pratico, insurrezionale in cui si spoglia la ricchezza della sua limitata forma borghese. Ma tale possibilità è contenuta nella stessa forma merce, nel dualismo di questa forma storicamente determinata della ricchezza e del lavoro che la produce.
Se la merce è contemporaneamente ricchezza materiale ed astratta, allora la non-identità è al centro di questa forma, rappresenta il suo carattere costitutivo. In altre parole, se la critica e la negazione della merce è possibile, lo si deve al fatto che la forma merce della ricchezza sociale non equivale a questa ricchezza; che solo in determinate condizioni sociali, materiali e storiche i prodotti della produzione umana prendono la forma, in alcun modo definitiva, del valore. Altrimenti, non sarebbe possibile pensare al suo superamento. Allora, se oggi l’emancipazione sociale radicale si presenta come comunizzazione è innanzitutto a causa delle trasformazioni reali del dispiegarsi storico della dialettica delle merce nel presente – che include al suo interno i rapporti di classe -; dialettica che può unicamente svilupparsi rinnovando costantemente la riproduzione sociale nella sua forma capitalista – un fenomeno che comporta ricorrenti ristrutturazioni dei rapporti di classe.
Non essendo, come apparentemente si presenta, una forma sociale infrangibile, l’intero quadro della socializzazione capitalista è attraversato dalla negatività: la sofferenza e il dolore irrazionale che provoca bastano ad indicare la possibilità, e la necessità, della cessazione di tale tortura, di un’altra forma di interdipendenza sociale non alienata. La forma storica necessaria di questo possibile è l’insurrezione come comunizzazione, quindi l’abolizione della condizione proletaria.
Il processo di comunizzazione, la produzione immediata della società senza classi nel corso di un processo di autotrasformazione sociale, non può che essere insurrezionale, movimento pratico di sovversione della dinamica della riproduzione sociale del capitale. Pertanto, la comunizzazione attacca la forma nella quale si riproduce e si perpetua in maniera allargata l’accumulazione capitalista. In questo senso, essa, in quanto movimento insurrezionale, non è unicamente volta alla soppressione della forma capitalistica delle relazioni sociali, ma costituisce altresì la concreta emergenza di un’altra forma di riproduzione sociale sorgente dalla negazione pratica del capitale. Come può essere possibile? Risposta: nel capitale tutto è praxis, reciproca produzione della società da parte dei soggetti, e dei soggetti attraverso la società. Il movimento globale del capitale è il movimento globale della prassi alienata – agente all’interno del metabolismo storicamente determinato della riproduzione sociale – sempre più autonomizzata dalla specie umana; si tratta quindi di una pratica sociale che tende a divenire relativamente indipendente dagli esseri umani e ad esercitare su di essi un dominio universalizzante.
La comunizzazione è possibile in quanto apertura di una crepa generata dalla contraddizione intrinseca alle forme sociali capitaliste nell’attuale stadio di crisi della civiltà del lavoro salariato. Il processo di comunizzazione emerge a partire da e in contraddizione con le forme sociali capitaliste.
Non insisterò ulteriormente nel rimarcare l’assenza di un’alternativa d’emancipazione alla catastrofe capitalista che provenga da una dimensione esterna a queste forme di socializzazione o dalla pura volontà [degli individui]; la negazione pratica del capitale si sviluppa dalle crepe che si aprono nel corso del suo proprio movimento contraddittorio.
Che dire dunque di queste crepe? Esse sono i punti di apertura presenti nel rapporto capitalistico che permettono di rompere con la socializzazione capitalista, a partire dalla sua stessa dinamica contraddittoria. A questo proposito, Theorie Communiste ha affermato qualcosa di fondamentale.
Se il proletariato può agire solo come classe di questo modo di produzione, e per esistere deve farlo essenzialmente in quanto classe del capitale, come può abolire le classi e produrre l’emancipazione sociale?
Risposta: esattamente perché agisce puramente come classe, esso mette in discussione la propria stessa riproduzione. Ecco la crepa: la messa in discussione della propria condizione di classe attraverso l’azione di classe, in cui si rintracciano al contempo i limiti e le potenzialità sovversive delle lotte attuali, giacché in esse scorgiamo come effettivamente si aprono delle fratture nelle quali le masse insorgenti, attraverso le loro azioni, rompono potenzialmente con la condizione proletaria; nel farlo però, per mezzo della loro attività pratica e delle loro rivendicazioni – soprattutto quelle salariali – rinforzano e ricostituiscono anche la propria condizione di classe.
Il compito di una teoria critica radicale consiste quindi nel produrre le condizioni di possibilità per l’autochiarificazione della prassi collettiva, non tanto indicando ciò che risulta necessario fare, quanto mostrando attivamente i suoi limiti in un dato momento, assieme al versante in cui essa tende a ricostituire i rapporti sociali capitalistici perturbati dal movimento sovversivo.
Questo ci porta necessariamente sul piano della mediazione tra critica radicale e movimento reale, ovvero al problema della prassi concreta che deve dotarsi di strumenti specifici per essere incisiva. Su questa base, le minoranze rivoluzionarie e le individualità che si adoperano nella critica radicale – con maggiore o minor rigore, bisogna dirlo – non sono altro che espressioni delle possibilità di emancipazione che albergano oggettivamente nella società capitalista.
La genialità di Karl Marx non derivava da una mente superlativa o specialmente dotata, bensì dallo sviluppo di una teoria capace di riflettere sul proprio condizionamento storico, cioè della sua determinazione in quanto possibilità dell’oggetto stesso della propria critica, il capitale. Questa è l’origine della permanente attualità di suddetta critica immanente alla socializzazione capitalistica, che persisterà fintanto che lo farà il suo stesso oggetto.
Allo stesso modo, la prospettiva da me esposta è storicamente determinata; la sua validità conserva il senso di una possibilità interna alla crisi della civiltà capitalistica, e in nessun modo può andare oltre le circostanze che la determinano. Il suo contenuto è l’emancipazione sociale come comunizzazione, il freno di emergenza che si qualifica simultaneamente come critica in azione della socializzazione capitalistica e produzione di un modo di vivere liberato. Questa è la forma necessaria per sventare nell’attuale arco storico la catastrofe capitalista, che comunque non costituisce affatto il percorso conclusivo verso l’emancipazione sociale e nemmeno la sua garanzia di successo. Al contrario, come vedremo nelle prosecuzioni di questo scritto, oggi le possibilità di critica e quindi di superamento del crollo capitalista sono sempre più compromesse.
Risulta comunque necessario approfondire il carattere pratico del processo di comunizzazione – facendolo non posso evitare di riconoscere i miei limiti, frutto dell’offuscamento prodotto dalla socializzazione capitalistica –; non può esistere una ricetta universale per l’emancipazione umana, perché la sua condizione di possibilità va cercata nella totalità oggettiva dell’intreccio sociale, tra le crepe della socializzazione che, seppur rispondenti ai medesimi principi, cioè alla forme sociali fondamentali della modernità capitalista: valore, merce, lavoro, denaro, capitale, ecc, non sono mai pienamente sovrapponibili.
Il processo di comunizzazione, per essere tale, deve innanzitutto tendere alla soppressione della condizione proletaria, fondamento della valorizzazione del capitale. L’obiettivo che fornisce l’impulso alla cieca traiettoria storica della produzione capitalista è raggiungibile solo attraverso l’accumulazione di plusvalore, il tempo di lavoro eccedente [a quello necessario per riprodurre la forza lavoro] estorto alla classe operaia globale, senza alcuno scambio di equivalente. Di conseguenza, la merce come forma fondamentale della civiltà non può essere compresa senza il pluslavoro in essa contenuto. Infatti, nella produzione capitalista, ogni merce è costituita da tempo di lavoro oggettivato, da lavoro eccedente estorto alla classe salariata. La classe operaia è così, come suggerisce Theorie communiste, merce per eccellenza fra tutte le merci, fondamento reale della riproduzione allargata del capitale.
La critica in azione della socializzazione capitalistica comporta l’interruzione del rapporto-capitale e la messa in discussione della riproduzione della classe salariata come classe operaia, dunque la necessaria trasformazione della riproduzione sociale, non più mediata dalle forme sociali capitaliste: la libera distribuzione dei beni quale prima prima misura pratica del processo insurrezionale.
Più semplicemente, è necessario che l’insieme delle masse proletarizzate – inclusi ovviamente i disoccupati, sottoproletari, precari, ecc – possano riprodurre la propria esistenza fisica facendo a meno della mediazione del lavoro, del denaro e della forma merce.
Bisogna allora far notare che il tiro del freno d’emergenza implica non solo la produzione di una rottura – il momento di deflagrazione insurrezionale, del saccheggio, della distruzione dell’infrastruttura del capitale – ma anche un diverso orientamento della riproduzione sociale, a partire da quello che è nella sua forma capitalista.
Il processo di comunizzazione è quindi impensabile senza l’appropriazione collettiva degli strumenti della riproduzione sociale, dei cosiddetti mezzi di produzione che però, pur essendo, assieme alla loro socializzazione da parte delle masse salariate, una componente classica del repertorio leninista della rivoluzione, non comporta necessariamente il superamento del capitalismo. Di fatto, come nel caso dell’URSS, quest’ultimo può essere ricostituito proprio a partire da tale appropriazione.
Quel che risulta determinante è la forma della riproduzione sociale; i rapporti sociali capitalisti sono perfettamente compatibili con l’appropriazione proletaria dei mezzi di produzione. Tanto più che essi attualmente si presentano in una forma oggettivamente legata al capitale e modellata dall’obiettivo propulsore dell’intera dinamica sociale presente: il valore che si valorizza.
Non si tratta di appropriarsi delle industrie per riprodurre al loro interno i rapporti che le rendono ciò che sono, bensì di riappropriarsi della prassi sociale oggettivata in tali strumenti riorientando la riproduzione sociale su nuove basi: la diretta soddisfazione dei bisogni umani e la produzione del tempo di vita. D’altra parte, una quantità enorme di macchine ed industrie è tremendamente nociva, inquinante ed oggettivamente distruttiva delle condizioni biofisiche del pianeta; un processo insurrezionale vittorioso dovrà smantellare l’intera infrastruttura devastatrice e assicurare contemporaneamente la sopravvivenza degli individui attraverso una nuova riproduzione sociale orientata a produrre una crescente abbondanza di tempo di vita, quindi di ricchezza materiale.
Una riappropriazione liberatoria dei mezzi di produzione, che si accompagna a quella del nostro rapporto con la Terra su una rinnovata base sociale, necessita di una rottura col suo carattere capitalista, perciò richiede il reindirizzamento della produzione verso la soddisfazione diretta dei bisogni umani nel corso del processo insurrezionale.
In ogni caso, non è possibile vivere di saccheggio che, nella sua forma capitalistica attuale – per come si è presentato durante le rivolte degli ultimi due decenni – si basa su una massiccia produzione di merci. Analogamente, nessuno si metterà in gioco in una rivoluzione incapace di garantire il pane alle persone insorte (si pensi al clamoroso fallimento del potenziale della rivolta cilena del 2019); un processo insurrezionale non in grado di riorientare la produzione sociale su altre basi è destinato a essere sconfitto dal recupero istituzionale, prima dalla forza d’inerzia dei rapporti sociali capitalisti e poi da una violenta controinsurrezione volta a impedire il ritorno della rivolta generalizzata. In assenza di reali orizzonti alternativi, le masse salariate torneranno tra le braccia delle istituzioni del capitale e vorranno a tutti i costi il ritorno alla normalità, la protezione dello Stato, finendo per sputare sulla propria recente rivolta. Qualsiasi ribellione interna al capitalismo può rapidamente convertirsi in una ribellione conservatrice e restauratrice della socializzazione capitalistica grazie all’esercizio della violenza di massa. La fase immediatamente successiva alla rivolta in Cile è ancora una volta esemplificativa; attualmente le condizioni sociali sono forse peggiori di quelle alla sua origine, ma il corpo sociale sembra essersi orientato verso prospettive reazionarie.
Consentire al potenziale emancipatorio che si agita nelle lotte sociali del presente di emergere apertamente e dispiegarsi pienamente significa assecondare l’apertura di crepe all’interno del rapporto capitalistico; il ché comporta necessariamente un’azione tesa alla riappropriazione del tempo alienato e dei mezzi di riproduzione sociale.
La rivolta in Cile, al pari di quelle avvenute in altri paesi, ha fallito precisamente nel realizzare il salto qualitativo che porta l’insurrezione generalizzata verso l’emancipazione sociale radicale. Il superamento di questa impasse va cercato nella prassi sociale contraddittoria dei movimenti di lotta e nell’opportunità di cavalcare coscientemente il loro potenziale.
Rispetto a questo, la teoria della comunizzazione ha segnalato la necessità delle cosiddette ”misure comuniste”, la forma concreta dell’attività pratica mediante la quale la socializzazione capitalistica viene soppressa e, assieme a lei, si autosopprime il proletariato, lavoro vivo preda della fame famelica di plusvalore del capitale.
La produzione di un’altra forma sociale, una forma di interdipendenza umana liberata, consiste nella moltiplicazione e generalizzazione di azioni che nel corso della lotta permettano, grazie alla partecipazione di diversi gruppi sociali, inizialmente di intaccare le forme sociali capitaliste, per poi sopprimerle, minando la forza politico-militare [nemica] organizzata dalla Stato e dai suoi agenti. Non è possibile sopprimere immediatamente il quadro di socializzazione capitalistica, ma si può mettere in movimento una prassi che dia subito corpo alle sue premesse. In questo senso, nonostante abbia precedentemente affermato che non esiste una ricetta generalmente valida per la produzione cosciente del comunismo, si può dire che la massima che nessuno patisca la fame riassume efficacemente il contenuto di una misura comunista essenziale per la prosecuzione dell’insurrezione e del suo rafforzamento nel corso del suo dispiegarsi.
Solamente misure comuniste concrete che consentano di orientare la riproduzione sociale nel senso della diretta soddisfazione delle necessità e della produzione di tempo libero di vita possono consentire al processo insurrezionale di sostenersi, espandersi e infine trionfare. Bisognerebbe allora declinare su basi rinnovate la massima marxiana per cui l’insurrezione è un’arte, nel nostro caso quella di far fiorire il tempo di vita – la prassi sociale vivente dell’umanità – liberandoli dal suo involucro capitalista.
[Ricevuto via e-mail e pubblicato in https://lanemesi.noblogs.org/post/2025/08/02/insurrezione-e-comunizzazione-ripensare-lemancipazione-sociale-radicale-in-una-nuova-epoca-di-catastrofi/]